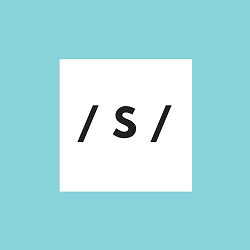Intervista a Giovanni Dozzini, autore di “Qui dovevo stare”, edito Fandango
Giovanni Dozzini nasce a Perugia ed è un giornalista e uno scrittore. Ha pubblicato diversi romanzi e ha vinto il Premio letterario dell’Unione Europea del 2019. Qui dovevo stare, pubblicato per Fandango è il suo ultimo romanzo. Abbiamo avuto modo di intervistarlo e di seguito nell’intervista trovate informazioni su di lui e sulla sua ultima opera. L’autore ci parla infatti della struttura narrativa di “Qui dovevo stare”, del suo rapporto con il protagonista e delle riflessioni che accompagnano temi attualmente scottanti come quello della xenofobia e della situazione politica italiana.

Luca Bregolisse è un personaggio complesso, ha zone di luce e zone d’ombra. L’empatia tra lettore e personaggio è qualcosa che avevi previsto? È questo che rende umano il tuo protagonista?
In realtà lo avevo non solo previsto, ma anche auspicato. Ogni volta che si dà vita a un personaggio si immagina che il lettore possa empatizzare, anche se fosse il più truce degli uomini. A maggior ragione, nel momento in cui si sceglie un registro come quello che ho scelto io: tu metti il lettore dentro alla testa di un personaggio e gli fai vedere in presa diretta quello che questo personaggio pensa, quello che sente, le emozioni che prova… è inevitabile che si empatizzi. Io ritengo che nella letteratura non ci debbano proporre visioni granitiche del mondo, non devi dare risposte ma lasciare che il lettore si ponga domande. Entrare nella testa di una persona mi è parso un buon modo di farmi delle domande, soprattutto su questo tipo di persona, e perché se le facessero i lettori, che dopo che finisce il romanzo comincia a vedere la realtà come qualcosa di più complesso rispetto a quello che siamo abituati a pensare.
Il modo in cui riesci a far immergere il lettore nella psiche di Luca è autentico, realistico e coinvolgente. È stato complesso creare un personaggio letterario i cui pensieri fossero così divergenti dai tuoi?
È stato molto stimolante e, per certi versi, divertente. Diciamolo, la letteratura è anche un modo per indossare panni che non si indossano di solito e per vedere l’effetto che fa. Quindi, per me è stato stimolante cercare innanzitutto di non seguire un paradigma. Io non ho pensato di prendere a tavolino un tipo con delle caratteristiche ben precise. Avevo in mente la faccia, “il muso” – come direbbe Luca – il suo spirito, la sua attitudine di base. Però poi l’ho scoperto andando avanti. “Difficile”, direi di no. In passato ho scritto di altri personaggi con cui non avevo un’affinità piena (donne, preti, migranti, ecc): questo è un esercizio che si fa sempre. Nel momento in cui poi si adotta il flusso di coscienza, un monologo ininterrotto, è chiaro che devi entrare ancor più in quella prospettiva. Però non è stato difficile per me in questo caso.
Cosa pensi del fatto che un piccolo seme di xenofobia è presente in ogni uomo? Pensi che in alcuni questo seme germogli perché nutrito e che altri, invece, riescano a tenerlo sopito? Esistono persone in cui questo seme non esiste affatto?
Penso che la xenofobia sia radicata in maniera naturale in ogni animale. Qualsiasi animale ha paura di un animale diverso. Tutti gli uomini per reazione alla diversità tendono a irrigidirsi: ma a differenza delle bestie, noi dovremmo avere la capacità di elaborare i nostri istinti, le sensazioni che emergono in maniera inconscia. La paura di ciò che è differente da noi è inevitabile, però noi possiamo elaborarlo, e non sempre ce la facciamo: anche quelli più “progressisti”, più ben disposti, ogni tanto cedono. Ognuno di noi è diverso: ad esempio, a me la diversità ha sempre incuriosito parecchio, e quando crescendo ho avuto a che fare con persone provenienti da posti molto diversi dal mio, io l’ho sempre considerata una ricchezza. Dipende dal posto in cui nasci, come dal tempo in cui nasci. Però, allo stesso tempo, non posso negare che certe volte anch’io ho provato degli “irrigidimenti”, questo è inevitabile. Dopodiché c’è chi non si pone il problema di elaborare. Bregolisse non è xenofobo, anche lui ha un rapporto molto complesso con la diversità.

Sul finale, si avverte con forza il senso di compartecipazione che sente Luca. “Qui dovevo stare”, una responsabilità così necessaria da costringerlo a ignorare tutto il resto del mondo. Attualmente si ha lo stesso livello di partecipazione nei partiti di sinistra? La “chiamata alle armi” della destra è più forte? Perché?
Nei momenti di crisi, economica e sociale, come quello che stiamo attraversando da quasi 15 anni (dal 2008), è più facile per i partiti conservatori, di destra, essere attraenti, perché il messaggio che danno è semplice: serve più sicurezza, dobbiamo tornare a come stavano le cose prima, preservare lo status quo. È più facile dare la colpa della condizione economica attuale a un capro espiatorio, come gli immigrati. I messaggi sono più semplici e funzionano meglio, questo è un dato di fatto. Quando le cose vanno male, è più facile andare dal poliziotto cattivo, perché ti dà più sicurezza. La sfida per chi sta fuori o dentro i partiti è cercare di capire la complessità dei nostri tempi e provare a trovare delle soluzioni nuove. Io ho un grande rispetto per chi fa politica; sono deluso dagli esiti degli ultimi anni, sicuramente, ma è un mestiere pesante e di grande responsabilità. Chi fa politica è espressione di chi non la fa, il grosso del paese: se non c’è un “vero” partito di sinistra in Italia un po’ è anche colpa mia e di quelli come me.
Qual è la più grande differenza tra i tuoi quarant’anni e i quarant’anni vissuti da tuo padre?
Mio padre aveva 40 anni quando sono nato io, e lui è andato avanti per inerzia: la sua vita è migliorata, anno dopo anno, a partire da un certo punto, dal momento in cui ha cominciato a lavorare. La sua vita ha preso una piega consueta: il lavoro andava bene, guadagnava sempre di più, ha messo su famiglia. L’unico imprevisto dei suoi 40 anni sono stato io probabilmente, aveva già due figli grandi. Lui dal punto di vista politico è stato comunista da ragazzo fino alla fine, militante, è andato ai funerali di Togliatti. Io invece sono nella temperie più assoluta. Certo, ho scelto di fare una vita molto diversa da quella di mio padre, ma in comune abbiamo avuto l’idea di lavorare da “battitori liberi”: mi ha insegnato che la libertà di decidere del proprio lavoro è molto importante, il non lavorare da dipendente. Ma lui era un battitore libero che a 40 anni stava bene, io a 40 anni sono un “non proletario” vero: se uno vuole fare lo scrittore, lo sa che poi i problemi son questi. La differenza è questa.
Una domanda da lettore a lettore: quali letture hanno costruito la tua visione del mondo? Quali autori devi ringraziare per l’uomo che sei al giorno d’oggi?
Penso a Vittorini, che per me è stato molto importante da adolescente e tutt’ora da adulto, continua a dirmi molto per il modo in cui ha interpretato il suo lavoro di scrittore, nel mondo dell’editoria, di intellettuale nel suo rapporto con la politica, nell’idea che la letteratura sia sempre anche politica, che incide su chi legge. Uno scrittore per me enorme è Javier Cercas; in tutti i suoi libri è riuscito ad aggiungere qualcosa all’idea di letteratura che dovremmo avere in questo momento. Uno dei debiti letterari di Qui dovevo stare è David Peace: ha una scrittura molto sincopata, a volte inintellegibile. E nel monologo di Bregolisse, ogni tanto, un po’ di Peace viene fuori.