Prima di spiegare per quale motivo non amo l’itanglese è bene che mi presenti rapidamente, perché chi mediti i miei nome e cognome si dirà in automatico: “Eccolo là, il francesone spocchioso e sciovinista per motivi genetici”. Non me la prendo nemmeno, abbiamo tutti i nostri difetti.
Cenni sull’autore: un ragazzo sessantenne
Sono un ragazzo sessantenne, docente di lingua araba a La Sapienza, francofono incallito sin dalla nascita benché ormai italianizzato e titolare di cittadinanza italiana, vivo a Roma da quando avevo quattro anni. Ho una formazione da linguista, oltre che da arabista, ritengo in quanto tale di non parlare soltanto dei miei gusti linguistici personali. L’italiano non essendo la mia lingua, potrei anche benissimo fregarmene. Sono cresciuto comunista, quindi mi reputo del tutto scevro di nostalgie fasciste. Sono il primo a dire okay, film, weekend, look, fast food e tant’altro, e sono ben contento che gli omosessuali abbiano diritto oggi a essere chiamati gay, altro anglismo, e non più con termini offensivi. Prestiti da altre lingue esistono in tutte le lingue del mondo, sono un segno positivo di apertura su “l’Altro”.
In Italia fu la dittatura fascista a vietare l’uso di parole straniere, e non rivendicherò mai il ripristino di un simile procedimento. Significa questo che un bravo antifascista deve fare incetta di prestiti, dall’inglese s’intende, per non essere sospettato di rimpianti destrorsi? Quello che pratico io lo chiamo ecologia linguistica, nel senso che la lingua ‒ e i dialetti ‒, per come la vedo, fanno parte dell’ambiente e pertanto hanno diritto allo stesso rispetto che tributiamo a mari, fiumi, foreste e paesaggi in generale.
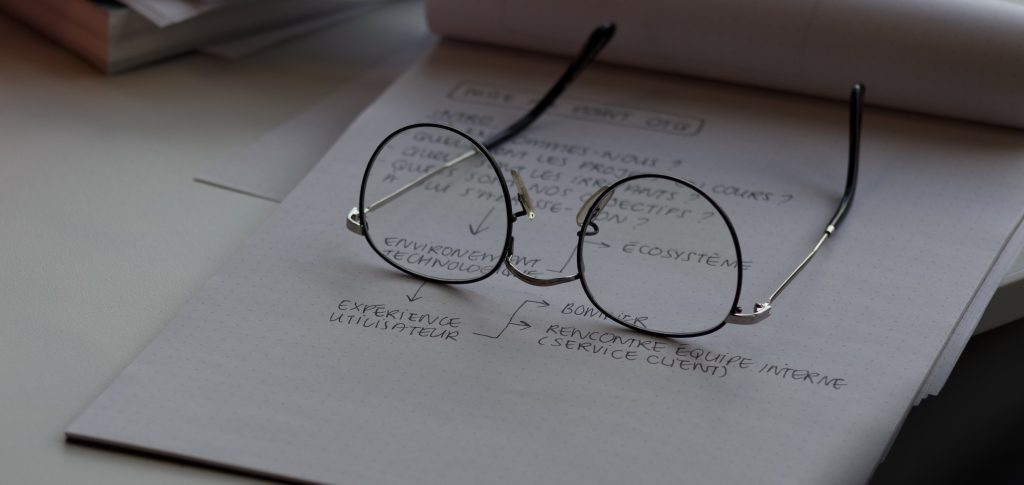
Per una militanza linguistica
Non pretendo “leggi”, né tantomeno “sanzioni” per chi preferisca esprimersi in itanglese. Siamo in democrazia e ognuno deve essere libero di parlare come meglio ritiene. Il linguaggio rientra nei fenomeni di moda: vanno, vengono, spariscono, ritornano, e soprattutto cambiano con il tempo. Ma esistono mode ridicole (come di recente il dilagante car* tutt*). La mia non è altro che una militanza che suggerisco ai tanti che la pensano come me. Infatti so bene di non essere l’unico, ma ci percepiamo come una minoranza indesiderata che fa meglio a tacere in quanto tacciata di “ridicola”.
Vedrei tuttavia di buon occhio qualche disposizione da parte del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) da impartire alla Scuola e all’Accademia, e sarei felice di trovare nella mia posta elettronica inviti a “seminari in linea” anziché webinar (o perché non innovare anche noi con retinario, o se proprio ci teniamo webinario per webeti?) e a corsi sulla “riservatezza” invece di privacy.
Quella spocchia alla francese
Ora, la Francia spocchiosa è ben lungi dall’essere l’unico Paese occidentale a raccomandare (ma non certo rendere obbligatorio) l’uso di termini tradotti (cosa che la maggioranza dei francesi trova perfettamente normale): ordinateur“computer”, matériel “hardware”, logiciel “software”, balladeur “walkman”, centre d’appels “call centre”, souris (lett. “topo”) “mouse” ecc. Lo fanno anche gli altri stati, occidentali e non.
In Italia “si dice” password perché “Eh sì, ormai è entrato nell’uso, che ci vogliamo fare?”, e secondo non pochi è “intraducibile”!
Francese: mot de passe, spagnolo: contraseña, portoghese: senha, tedesco: Passwort, danese: adgangkode, polacco: hasło, arabo: كلمة السر, ebraico: סימסה, turco: şifre. Tutti fascisti e “ridicoli”?
Escludo le attività commerciali: se ritengono di guadagnare di più o di attirare più clienti con l’itanglese, niente da ridire, la mia censura abbassa le braccia. L’economia globale è tuttora basata sul commercio ed è ben risaputo che la maggioranza della popolazione bipede di questo Pianeta ama la moda.
Ma siamo arrivati a soglie di assurdità. Se spiego che, visto le misure di confinamento, devo fare gli esami in linea, e per generare il collegamento declinare nome utente e parola d’ordine, molti non mi capiscono. Per essere compreso devo dire che per via del lockdown ho dovuto accedere online al link con user name e password. Scusatemi ma no so se ridere o piangere.
Il problema dello scrittore contemporaneo
Sono anche scrittore in lingua italiana: quanto devo litigare con i consulenti editoriali ‒ anzi gli “editor” ‒ che senza nemmeno consultarmi mi correggono nebulizzatore in spray, tassì in taxi, o mi bocciano le parole che vanno oltre le cinquecento del lettore medio (che chiamo “mèdiocre”).
Trovo stomachevole quanto il ketchup sui maccheroni devolution “decentramento istituzionale”, newtown “piano di ricostruzione edile provvisoria”, ticket “tassa sulle prestazioni sanitarie”, austerity “austerità”, spending review “tagli sulla spesa pubblica”, JOBS act (acronimo di Jumpstart Our Business Startups Act) “riforma del diritto del lavoro” ‒ spesso scrittoJob’s act “atto di [un misterioso] Giobbe” ‒, per non parlare di un recovery fund “fondo di recuperi” di cui molti non capiscono neppure il significato. Eh, ma troppo lungo, in italiano! Allora viva la neologia e gli scorciamenti: decentramento, neocittà, sanitassa, austerità, tagli, e visto che DPCM non ci spaventa perché non RDL?
No, non si tratta di una “battaglia di retroguardia”, ma di un atteggiamento didattico condito da un indispensabile pizzico di autoironia.

Itanglofilia dilagante
Mi dispiace, ma quest’itanglofilia strisciante e ormai proliferante è una sindrome, preoccupante, di depauperamento di una cultura italiana sempre più mèdiocre, e i tanti che difendono l’itanglese come necessario, inevitabile, ormai irrinunciabile mi fanno soltanto cagare. E ai tanti che mi riferiscono di aver tradotto un testo inglese di cento parole con centocinquanta italiane, mi rincresce, ma questo è il primo sintomo di chi non sa tradurre. La traduzione è un mestiere, che occorre imparare.
Quante volte sento dire che, eh sì, l’inglese è più “stringato” dell’italiano, ricorre a meno parole per dire le stesse cose… Che lingua agile e sciolta…! Facciamo un esempio. Salgo su un qualsiasi aeromobile di Alitalia, e mi siedo al posto assegnatomi. Sullo schienale della poltrona di fronte a me leggo la seguente scritta bilingue:
Life jacket under seat
Il giubbotto salvagente si trova sotto la propria poltrona
Ebbe’, sì… quattro parole inglesi contro nove italiane… bisogna riconoscere… in effetti… Qui ci vuole un excursus storico e linguistico. In base a direttive rivolte alla lotta contro l’analfabetismo, sin dagli inizi del Novecento gli Stati Uniti hanno deciso di ricorrere il meno possibile a segnali, preferendo loro ingiunzioni scritte. Laddove in Italia abbiamo un cartello circolare azzurro con una freccia bianca rivolta verso destra, in America troviamo la scritta “turn right”. Ora, turn right si legge e assimila in fretta. Ma un’indicazione più articolata, come Attenzione al pericolo di smottamenti improvvisi, tenersi rigorosamente sulla destra e moderare la velocità, può rivelarsi controproducente, in quanto l’automobilista intento a decriptare tutto con attenzione si distrae dalla guida e fa largamente in tempo a finire contro un palo o in fondo al burrone.
Lingua e segnali stradali
Questo ha portato gli americani a “limare” quanto più possibile le segnalazioni, stradali o altre. Life jacket under seat, letteralmente “salvagente sotto sedile”, non è inglese né letterario né colloquiale, che direbbero piuttosto the life jacket is under your seat, sette parole: sempre meno di nove… In Italia non siamo abituati a queste potature sintattiche. Bisogna spiegarci tutto. Del salvagente viene precisato che si tratta di un giubbotto salvagente, affinché qualcuno magari non immagini una ciambella con la papera. Si trova, nel senso che occorre cercarlo. Sotto la propria poltrona, altrimenti l’italiano lo va a prendere d’istinto sotto il sedile che ha davanti a sé. È così che, alcuni anni fa, apparve sulle portiere posteriori dei tassì italiani, in corrispondenza della maniglia, la scritta bilingue:
Chiudere piano
Close soft
All’attenzione di quei clienti zelati che sbattono la portiera come se dovessero schiaffeggiare un ippopotamo. Ora, a parte il fatto che close soft in inglese significherebbe “chiudere con dolcezza”, o “delicatezza”, premura tutto sommato eccessiva nei confronti di una carrozzeria d’acciaio temprato, sulle portiere dei tassì britannici leggo:
Please, do not bang the door
Con tanto di please, di virgola e di do not anziché don’t: questa volta, due a sei per l’italiano.
Gli studenti che non sanno il francese (lasciamo stare il tedesco) non soltanto non lo sanno ma sono ben determinati a non saperlo mai. Ora, in Russia, Cina, Giappone, Corea non accettano l’inglese come esperanto (chiamiamolo a questo punto esperanglo): o ti impari russo, cinese, giapponese, coreano o te ne torni a casa. In Francia, poi, provate a ordinare in inglese in un negozio o ristorante, udirete le male parole.
Appartengo come già detto alla comunità di italiani di origine straniera: tra di noi parliamo in varie lingue, anche italiano, va senza dire, e assistiamo al proliferare dell’itanglofilia tra incomprensione e sonore sghignazzate, perché il fenomeno è caricaturale e a momenti avvilente.
Ma l’inglese è più “pragmatico”, sento spesso affermare: si fa prima a dire jetlag e feedback che “mal di fuso” e “ritorno d’informazione”. Allora proponiamo fusopatia e un semplice ritorno risemantizzato (che peraltro sento in bocca alla mia salumiera a proposito dei commenti dei clienti su dati prodotti). Per stalking esiste uno splendido assillo, e quanto al computer ormai inestirpabile, in Svizzera lo chiamano ordinatore. Volere è potere.

Rispolverare la cantina
Esistono anche parole italiane oggi in totale disuso che potrebbero essere riattualizzate, come stazzone (maschile o femminile, stessa etimologia di stazione), che si riferiva alla bottega (e spesso abitazione) dell’artigiano, per workshop. Lo ha fatto l’arabo in diversi casi: nella lingua standard attuale l’automobile e il treno sono chiamati sayyāra e qiṭār, che oggi significano soltanto questo, ma in antico arabo erano il “dromedario da corsa” e la “carovana di montagna” con i dromedari in cordata come vagoni.
Usare l’aureolante itanglese, che per molti italiani viene vissuto come un non problema, viene sbandierato come “più moderno”. Ora la domanda è: chi è più moderno, chi opta per aggrapparsi a un’altra lingua, o chi affronta la modernità adeguandovi la propria? “Modernizzarsi” significa rinunciare alla propria identità culturale? Così pare di capire, e con buona pace dei francesi snob e spocchiosi.
Concludere con filosofia
Quanti sanno che l’italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, e che l’insegnamento dell’italiano all’estero è oggi una carriera professionale in pieno sviluppo per i laureati in lingue? Devo andare a Londra, Washington o Canberra per insegnare che computer, lockdown e call centre in italiano si dicono computer, lockdown e call centre?
Ma concludiamo con una sana filosofia napoletana: ce la ricordiamo la canzone Tu vuò fa l’americano di Renato Carosone, del 1956? Allora, che cosa stigmatizzava, quella canzone? La persona che, a torto o a ragione, si sente provinciale, e cerca di rimediare a tale condizione assumendo una serie di comportamenti vari ‒ whisky and soda e rock and roll… ‒, con tuttavia il risultato che così facendo non fa altro che accentuare il proprio aspetto provinciale. Moralità della favola: Sient’a me, chi t’o fa fà?
Io milito! Chi mi ama mi segua. Nei tre giorni scorsi ho causato diverse fissità dello sguardo dichiarando di aver preso una tachipirina prima di recarmi al vaccinodromo per il richiamo del vaccino anticovid. Mi rifiuto di dire all’hub, pronunciato ab(be).
Faccio ridere? Benissimo, un professore che non sa far ridere ogni tanto non sarà mai un buon professore.
Articolo di
Olivier Durand
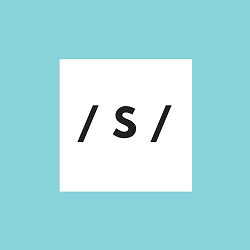








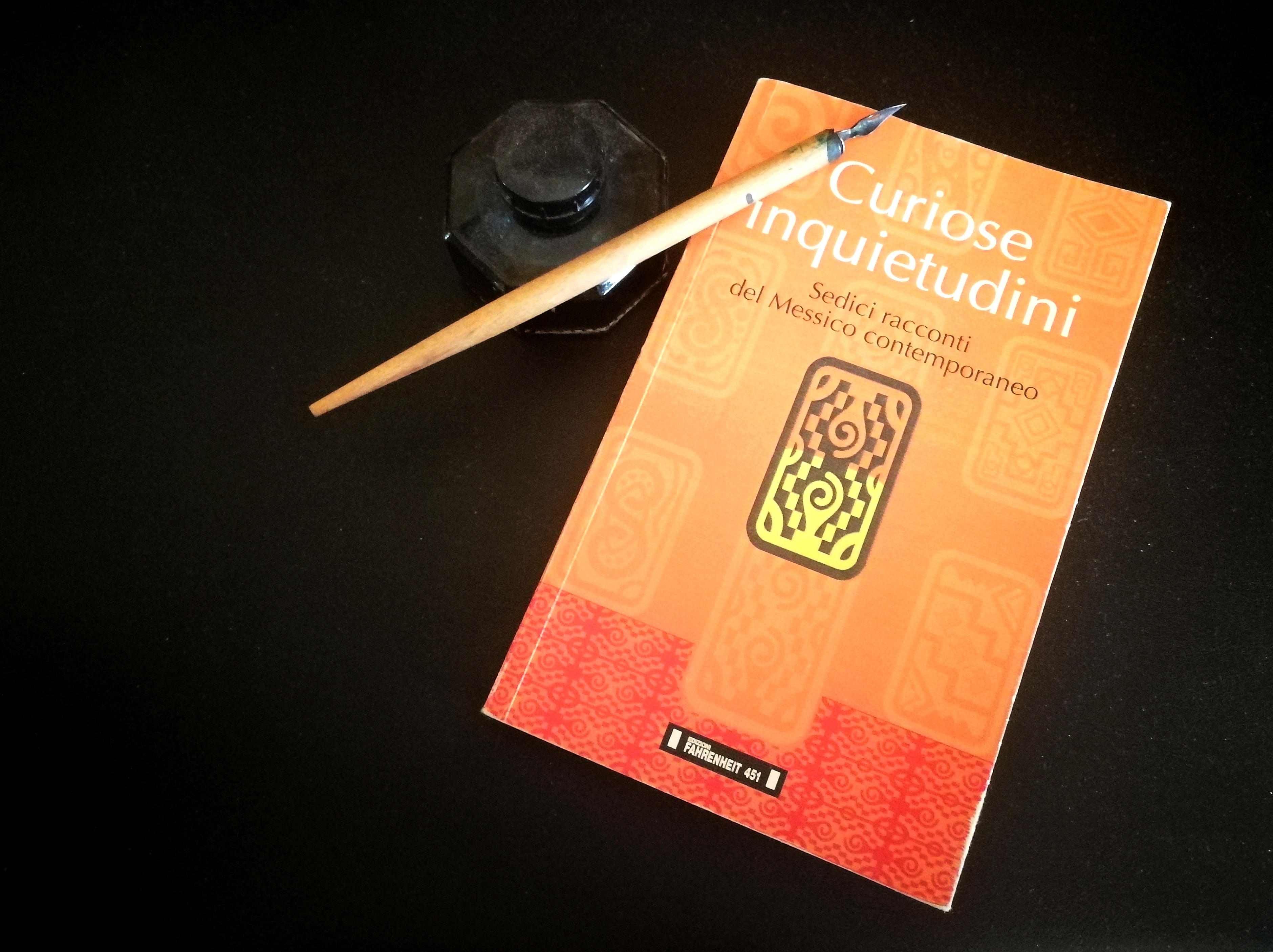
Grandissimo e colto articolo, ineccepibile sul piano logico, assolutamente condivisibile e scritto con toni tanto indignati quanto leggeri e con grande senso dell’umorismo. L’Abbe (Hub dei romani), il Salvagente sotto la poltrona altrui e l’Atto di Giobbe meritano applauso.
Sono stata, non lo so dire in inglese, schernita per aver scritto più o meno le stesse cose, naturalmente non così bene come lei, dopo aver letto un articolo su fb. Io sono anziana ma amo molto leggere, perché devo cercare le parole inglesi sul vocabolario per capire quello che sto leggendo? È così bella ed espressiva la lingua italiana e penso che, come me, tante persone anziane abbiamo lo stesso problema. Grazie per le sue parole, non mi sento più una stupida vecchietta
Sempre simpatico e originale, Olivier! oltreché acuto.
Beh io in partenza sono d’accordo. Che ci crediate o no, io “week-end” non lo dico e non lo dirò mai. Mi piace dire il “fine settimana”. Mi pare di essere l’unico, però. Certo, dico “ok” (anche se sto cercando delle alternative) e “computer”, che – in effetti – allo stato attuale delle cose è forse inestirpabile. “Ordinatore” non mi convince… il corrispettivo sarebbe, forse, “calcolatore”? . Mi faccio remore su “online”, che sostituisco spesso dicendo “su internet”, ma non so se va poi tanto meglio!
Per quanto riguarda “feedback”, da me sempre boicottato, possiamo anche trovare sostituti assai più semplici ed efficaci: “resoconto”, “ritorno”, “parere”…..
Detesto anche sentire “andiamo a prenderci un drink”….. oh mio dio……per fortuna non ancora assolutizzato e sostituibile con “prendere un bicchiere di vino (per esempio)”, o, a Firenze, col gergale giovanile “bèuta” (che sta per bevuta, con cambio di accento).
Con questo esempio però, secondo me, si arriva ad un punto importante della questione: la totale e massiccia colonizzazione culturale angloamericana alla quale siamo sottoposti da…. un cinquantennio almeno?
è chiaro che se una delle fonti principali di intrattenimento delle giovani generazioni (arrivando ben oltre i trentenni) sono le serie sulle piattaforme “streaming” (e questo!?), ecco individuata una delle sorgenti maggiori di tutti questi “italinglismi”. (a mio avviso, questa influenza è ampiamente rintracciabile in altre nicchie della società, vedi i matrimoni e – nello specifico – gli addii al celibato e nubilato….)
Riusciremo a proporre alternative a questo modello comunicativo?
Sulla base del tuo articolo, anch’io posso ritenermi un militante! Ma di quanti potremmo dire lo stesso?
Grazie della riflessione
giovanni ragni
Comme te pò capí chi te vo bene si tu ‘nce parle miez’american?
Ottimo, sono 100% d’accordo con lei. L’altro giorno, in un bar nel cenyro di milano ho visto dei ragazzi (camerieri) con una maglietta che recitava: I’m on stage. Please be patient…..oppure L Mudec, il museo delle culture, al “giftshop” mi indirizza alla “bookshop” per comprare e un catalogo.. Ah, la libreria, rispondo. No. La bookshop perche non vendono solo i libri. Qui la logica (se mai ce fosse…) mi sfugge…..
Che piacere leggere questo arguto e simpatico articolo. Sottoscrivo tutto perché anch’io sono vittima di prese in giro, di osservazioni denigratorie, di incomprensioni varie per la mia ostinazione ad usare le parole italiane invece di quelle inglesi che vanno per la maggiore : mi rifiuto, fra mille altri esempi, di adoperare “lockdown” o “smart working”. Però, bisogna che lo confessi, sono nata in Francia, allevata ed educata da questa “spocchiosa” società. Vivo in Italia e lotto continuamente per far vivere questa bellissima lingua che è l’italiano.
Abbraccerei il professor Durand. A Roma ho visto un’insegna che inalberava “GELATERY”
TI AMO! Ho letto, anzi divorato, il tuo bellissimo articolo (e divertente, il che non guasta); sono d’accordo su tutto, sono una talebana dell’italiano… Grazie grazie grazie!