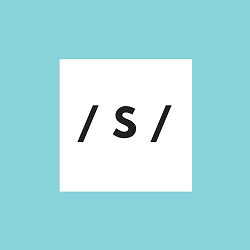Per arrivare a comprendere la vera natura dell’uomo greco di stampo socratico e, per contro, lo scarto essenziale che sussiste rispetto alla nostra modernità, è necessario compiere uno sforzo non da poco. Soprattutto per noi occidentali imbevuti di cristianesimo, romanticismo e diritto romano. Il fatto che la filosofia greca prima, e la svolta socratica poi, rappresentino una delle fondamenta essenziali della nostra cultura occidentale, non comporta automaticamente un’identificazione di vedute (Weltanschauung), né una medesima impostazione antropologica. Troppa acqua è passata sotto i ponti della Storia. E tale è la distanza da noi, che l’uomo greco che affiora dai testi della filosofia classica, è assai più vicino a Buddha che a Cristo. La figura di Socrate, la sua filosofia e la concezione della virtù sono il metro fondamentale per poter misurare questa distanza.
Ex oriente lux
Quello che si vorrebbe sostenere, qui di seguito, è che l’uomo greco della filosofia classica, è ancora intriso di un sano orientalismo, per cui il principio di individuazione non ha ancora attecchito: un uomo di tal sorta ancora non si percepisce come un essere differente e distinto nei confronti di tutti gli altri enti che lo circondano. Detto in altre parole, il rapporto Io/Mondo è ancora tutto a favore del secondo termine.
Questo tipo di ἄνθρωπος non si sente ”separato” dal mondo e dalle cose, ma parte integrante di un’unica entità oggettiva ed universale, che è appunto l’Essere: unico, inamovibile, eterno e sferico. Non è presente in lui quella radicale separazione tra Io e Mondo tipica della modernità occidentale, per cui l’individuo tende a considerarsi come ”altro” sia rispetto alla realtà stessa sia rispetto agli altri individui. E questo è ampiamente dimostrato dalla sua etica, dalla convinzione profonda dell’esistenza di una realtà oggettiva, che non minaccia l’uomo né lo inganna. Al contrario, la sua conoscenza è in grado di liberarlo definitivamente dalla schiavitù morale. Da qui un forte ottimismo nei confronti della vita e dell’esistenza, che sin da subito crea una distanza irrimediabile rispetto a noi moderni.
L’uomo e la Polis
Ulisse, Edipo, il sofista, il re filosofo, l’uomo dell’agorà e l’uomo del tempio hanno tutti una natura comune, una costante che potremmo rintracciare proprio nella ”partecipazione” al Mondo, in una stretta relazione con esso. Una partecipazione, però, che non ha nulla a che vedere con l’etica Romana (come vedremo), ma partecipazione nel senso di una ricerca di armonia con le leggi che lo governano.
Non è un caso, ad esempio, che l’uomo greco, in generale, concepisce sé stesso primariamente come cittadino, e cioè soggetto in relazione ad una comunità. Per la sua mentalità, che certamente gli deriva anche dal peculiare assetto di guerra del cosiddetto Ὁπλίτης, non è assolutamente pensabile che un uomo sia completamente isolato nella sua situazione personale. Addirittura, Socrate è così rispettoso delle leggi della città al punto da non rifiutare la morte (Critone). Appartenere a qualcosa, in questo caso alla polis, è imprescindibile: l’essere parte di un intero sistematico, di un corpo unico. Non si da schizofrenia tra il privato e il pubblico.
Unità di soggetto e oggetto
Vige, nel mondo greco, ”ancora” una visione per cui ogni ente è irrimediabilmente invischiato con la realtà e gli altri. L’Essere è un tutt’uno con il soggetto che lo percepisce. Senza sradicamenti di sorta. E se l’uomo è un tutt’uno con l’Essere, in quanto sua accidentale e transitoria manifestazione, allora ecco la volontà individuale è ridotta al minimo. C’è un modo reale ed oggettivo con delle leggi, alle quali l’uomo se vuole vivere bene deve accordavisi, accompagnarle e non deviarle.
La filosofia socratica e l’assenza della Volontà
Per Socrate, di fatto, il ”bene” e il ”male” come li intendiamo noi moderni, non esistono. Si può certamente commettere un errore di calcolo, optando per qualcosa che si ritiene essere il bene, ma che in realtà reca un danno, questo si, Socrate non lo esclude. Ma non si può commettere scientemente il male, e quindi scegliere ”volontariamente” ciò che non è corretto e che arrecherà di certo un danno. Si può solamente fare un errore di valutazione dovuto all’ignoranza dell’argomento, per cui si crede che qualcosa sia ”bene” ma in realtà non lo è. Conoscenza e ignoranza del bene sono qui le parole chiave.
In altri termini, se si fa del male, lo si fa solamente per ignoranza del bene. La virtù, pertanto, consiste nella conoscenza/sapienza che porta automaticamente ad agire in modo corretto e con beneficio per sé e gli altri. Inoltre, aggiungiamo, la distinzione morale tra la ”correttezza” e l’utilità di un’azione non sussiste nella concezione socratica: è un tarlo da salotto cristiano post-moderno. Tutto ciò che è bene, corretto, è inevitabilmente anche utile, nel senso di vantaggioso per colui che compie l’azione. La conoscenza diventa, in questo modo, decisiva per l’etica e la morale, al punto che il male assoluto è identificato con l’ignoranza.

Per un’etica epistemologica
Le prove di questa visione peculiare che elimina completamente dalla scena la Volontà sono disseminate un po’ ovunque. Oltre che nell’Apologia, anche nel Critone, in cui Socrate afferma: ”Ho sempre cercato di orientarmi unicamente in base al ragionamento che, dopo una ponderata riflessione, si rivelasse il migliore” (Platone, Critone, 46 B). E, ancora, proprio nell’Apologia, Socrate accosta la perfezione morale dell’anima alla sapienza: ”Diventare migliore e più sapiente, avere un’anima il più possibile perfetta” (Platone, Apologia, 36 C). Conoscenza, virtù, ma anche piacere, tanto che Socrate arriva a dire: ”E il massimo piacere è sapere che ho sempre vissuto in modo pio e giusto” (Senofonte, Apologia, 5). E, parlando di ciò che è pio, buono e bello, Socrate, secondo Senofonte, diceva: ”Sono uomini virtuosi coloro che sono a conoscenza di queste cose, mentre si chiamano schiavi quelli che le ignorano” (Senofonte, Memorabili IV).
La conoscenza come virtù in Socrate
Ma, probabilmente, la massima espressione di questa concezione epistemologica dell’etica, viene rivelata da un altro dialogo, Il Protagora (352 B), in cui mentre il suo interlocutore afferma che la scienza non sarebbe in grado di comandare gli uomini, poiché essi sarebbero governati da altro (ira, piacere, dolore, amore, paura), per Socrate la scienza, al contrario, è ”bella e in grado di comandare le azioni dell’uomo, e colui che conosce i beni e i mali non può essere dominato da null’altro: basta la sapienza ad aiutare l’uomo”. Dunque vi è soltanto chi ”conosce” e chi ”non conosce”. La sapienza e conoscenza del ”bene” da sola garantisce da sola l’azione corretta che, a sua volta, coincide anche con quella che apporta maggior giovamento e quindi felicità per l’individuo. O meglio, diciamolo altrimenti: comportarsi correttamente consiste proprio nell’agire in modo vantaggioso.
Residui orientali nella concezione greca
Una domanda, ora, serpeggia nell’animo di noi moderni: come si arriva a questa concezione? Come è possibile rinnegare la volontà e quindi far aderire perfettamente conoscenza e corretta azione? La risposta poggia proprio su di una differente concezione gnoseologica della realtà, che avvicina il Filosofo e il mondo da lui rappresentato ad una visione orientaleggiante. Per l’uomo greco, infatti, esiste una ”correttezza” oggettiva che noi moderni stentiamo anche ad immaginare. Questo è il punto cardine di tutta la dottrina socratica, il tema su cui Platone incentrerà la sua stessa filosofia per difenderla dagli attacchi relativistici dei sofisti. Certo, è vero che i sensi ingannano, ma sotto il sostrato sensibile esiste una verità intelligibile, oggettiva, universale che sorregge il tutto: in una parola ”episteme” (ἐπιστήμη) letteralmente ciò che sta ”fermo” sopra il continuo fluire e mutare della materia. L’ottimismo di una verità celata, ma presente.

Assenza di una volontà
Per noi moderni, invece, è come se si dipanasse una certa difficoltà nel compiere il bene, poiché non solo bisogna conoscerlo, e può essere soggetto a relativismo culturale in quanto valore, ma poi è necessario anche sceglierlo. La conoscenza, in altre parole, deve accompagnarsi alla volontà, la quale ha tutta la libertà di opporvisi. Per tutta la filosofia greca agire correttamente non vuol dire sottostare ad un imperativo di ragione, come nel caso di Kant, ma è agire come un tutt’uno con le cose. L’etica ha un presupposto ontologico e naturale, non un fatto di cultura o ragione.
Potremmo spingerci oltre, ed affermare che questa ”correttezza” etica oggettiva, da cui scaturisce anche la nostra felicità, non dipende dai nostri bisogni, desideri o necessità (sono questi, infatti, tutti attributi di una soggettività già distaccato dal Mondo) ma dal Mondo stesso, dalla sua essenza. Ed ecco l’ottimismo.
Ottimismo perché tale concezione presuppone non solo un Mondo reale con una verità oggettiva che scalza tutte le altre, ma anche che ogni comportamento ‘accordato’ all’essenza delle cose porti inevitabilmente al bene e alla felicità. Tutto quello che l’uomo ritiene essere buono non è frutto di una determinata sovrastruttura storicamente determinata, o di una stagione culturale: il bene non è un valore relativo alla Storia e al cambiamento da essa sotteso. Il bene appartiene alla realtà esistente, ha un livello di dignità ontologica pari a quella delle leggi che regolano la natura.
Il diapason del Mondo
Dunque, agire correttamente non richiede il rispetto di una legge morale universale o relativa, né tantomeno un impulso che proviene da un impeto del cuore. Al contrario, procede da una chiara comprensione dell’essenza delle cose. Agire correttamente è un ”accordarsi” al diapason del mondo, come direbbe Cioran (Il Funesto demiurgo): essere in armonia con le leggi dell’Essere. Nessun ideale, nessun comandamento divino, ma la conoscenza di come stanno le cose nel mondo e la conseguente aderenza delle azioni che ne scaturiscono. E questo è possibile solamente in un mondo in cui l’Io non ha raggiunto l’ipertrofia moderna. In cui non ci si sente ancora sradicati dal Mondo, ma come un tutt’uno con esso. Da questa prospettiva, la storia moderna dell’Occidente appare come un progressivo ed irreversibile distaccamento della coscienza dal Mondo.
La svolta occidentale: Roma e Cristo
Ma prendiamo ora, un campione di modernità quale San Paolo, nella sua Lettera ai Romani VII: ”Vi è in me la volontà di fare il bene, ma non la capacità di attuarlo; non compio infatti il bene che desidero, ma il male che non vorrei” e poi, in modo ancora più lampante e struggente: ”Acconsento con gioia alla legge di Dio, ma nelle mie membra ne vedo un’altra, che muove guerra alla legge del mio spirito e nelle mie membra mi rende schiavo della legge del peccato”.
E facendo un salto brusco, ma necessario, di qualche secolo, lo stesso Kant continua su questa linea: ”Non vi è nulla al mondo, né è pensabile alcunché al di fuori di esso che possa esser preso senz’altro per buono fuorché una buona volontà” (Fondazione della metafisica dei costumi). Cristo, Lutero e poi Kant, in una coerenza folgorante di vedute. L’Occidente è ormai compiuto, la trasformazione antropologica è avvenuta. E, in mezzo, quel qualcos’altro di fondamentale che ha contribuito a foraggiare la Volontà, creando un vero spartiacque. Un’altra civiltà che, pur cibandosi della cultura greca, ne fece rinascere le istanze sotto altra forma, quella Romana.
Pericle aut Cesare
Mentre Pericle ”convinceva” i suoi con l’arte della retorica e la dolce musicalità delle parole, Cesare ”comandava”, così come l’intera civiltà romana tutta, tanto che Virgilio scrive:
Altri popoli, io credo, sono più abili
a conferire al bronzo il soffio vitale
e a far uscire dal marmo figure viventi;
altri sanno perorare meglio le proprie cause
e misurare con il compasso il movimento
del cielo e il corso dei pianeti:
Ma tu, o Romano, ricordati di governare i popoli
sottomettendoli al tuo dominio.
Le arti ti sono state date per imporre la pace
e il costume,
per risparmiare i vinti e vincere i superbi.
(Virgilio, Eneide VI, 847-853)
E comandare, esige una Volontà perentoria, chiara e lampante. E la Volontà è parente prossima della dinamicità e del movimento. Qui non è più questione di ”accordarsi” al Mondo, ma di plasmarlo: è appena iniziato il rovesciamo del rapporto Io/Mondo, ora tutto a favore del primo termine. E per plasmare il mondo non si ha certo bisogno della contemplazione e della conoscenza, bensì dell’azione. La staticità greca, qui, viene soppiantata da una concezione del mondo dinamica e spiccatamente romana. Il tutto condito anche da una maggiore sensibilità rispetto al senso della Storia. C’è un compito dell’uomo nella Storia secondo i Romani, un compito per una civiltà si concepisce quale ”agens”, e cioè in grado di forgiare il mondo e la materia.
Anche la divinità dei romani è del tipo agente, e diametralmente opposta a quella greca che coincide con l’Essere. E da questo sostrato antropologico, ecco che la volontà inizia a penetrare nell’etica, nella filosofia e nel carattere. Si pensi a Seneca, a quanto lo stoicismo romano sia differente da quello greco, e poi ancora Agostino e la patristica: tutto si riduce ad una questione di Volontà, al punto che Cristo può ben dire ”Beati gli ignoranti e i poveri di spirito” (Matteo, 5, 1-12). Qui, addirittura, la conoscenza sembra in sordina minare la purezza del cuore e le corrette azioni.

La trasformazione antropologica
Con i Romani prima, e il Cristianesimo poi, allora, si compie la trasformazione e nasce quella Volontà che rimarrà il tratto caratteristico essenziale del mondo come noi lo concepiamo. Ma nasce anche un altro tipo di uomo, quello moderno: individuale, solitario, chiuso in sé stesso, isolato dal mondo e dall’Essere, pur agendovi attivamente all’interno; sino ad arrivare alla liquefazione totale dei rapporti con l’altro (Baumann, Modernità liquida). Si crea uno scarto essenziale che porterà progressivamente all’ipertrofia dell’Io, dello spirito, e che ha prodotto la psicologia come suo ultimo rimedio.
C’è chi sarebbe disposto ad affermare che tutti i mali del mondo derivano proprio da ciò, recuperando qualche residuo di filosofia indiana. Così l’uomo moderno si sradica dall’Essere fino a rinunciarvi, fino a non avere più alcuna natura, se non un perenne e continuo coinvolgimento nel divenire. Ecco, dunque, che l’uomo occidentale, attraverso i secoli, è diventato l’incarnazione dell’inferno (Samsara) secondo l’Oriente: perennemente invischiato nel divenire e incapace di contemplare.