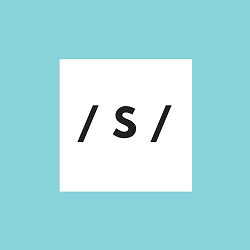L’unica registrazione della voce di Virginia Woolf è un audio di otto minuti realizzato per la BBC il 29 aprile 1937. Qui la scrittrice espone una riflessione sulla complessità delle parole e sul loro uso nel linguaggio moderno. La registrazione appartiene a un episodio della serie Words Fail Me (“Mi sfuggono le parole”), con un discorso intitolato Craftmanship (“Artigianato”). Proponiamo in questa sede l’audio originale dell’episodio e la traduzione in italiano.
Words, English words…
Le parole — le parole inglesi — sono per loro natura ricche di echi, di memorie, di associazioni. Sono andate in giro per così tanti secoli sulle labbra delle persone, nelle loro case, nelle strade, nei campi. E questa è una delle principali difficoltà nello scriverle oggi — poiché hanno accumulato molti significati, molte memorie, poiché hanno contratto molti matrimoni in passato.
La magnifica parola «vermiglio», ad esempio — chi può usarla senza ricordare anche «i mari infiniti»? In tempi antichi, certamente, quando l’inglese era una lingua nuova, gli scrittori potevano inventare nuove parole ed usarle. Oggi è abbastanza facile inventare nuove parole — sbocciano sulle labbra ogni volta che abbiamo una nuova visione o una nuova sensazione — eppure non possiamo usarle perché la lingua è antica. Non potete usare una parola nuova di zecca in una lingua antica per il fatto abbastanza ovvio, ma misterioso, che una parola non è un’entità singola e separata, ma è parte di altre parole. Non si tratta davvero di una parola, finché questa non è parte di una frase.
Le parole dipendono le une dalle altre, benché, di certo, solo un grande scrittore sappia che la parola «vermiglio» dipende da «mari infiniti». È inevitabile combinare parole nuove con parole antiche per la costruzione di una frase. Affinché possiate usare parole nuove in modo appropriato dovreste inventare una lingua nuova; e ciò, anche se vi arriveremo senza dubbio, non è di nostro interesse al momento. Il nostro interesse è comprendere ciò che possiamo fare con la lingua inglese così com’è. Come potremmo combinare le vecchie parole in un nuovo ordine affinché sopravvivano, affinché creino il bello, affinché dicano il vero? È questa la domanda.
E la persona che fosse in grado di rispondere a questa domanda meriterebbe qualunque corona di gloria il mondo possa offrire. Pensate cosa significherebbe se poteste insegnare, se poteste imparare l’arte della scrittura. Ogni libro, ogni giornale direbbe il vero, creerebbe il bello. Ma sembra ci sia qualche ostacolo lungo il percorso, qualche impedimento all’insegnamento delle parole. Sebbene in questo istante almeno cento professori stiano tenendo conferenze sulla letteratura del passato, sebbene almeno mille critici stiano analizzando la letteratura del presente, e centinaia su centinaia di giovani uomini e donne stiano superando un esame in Letteratura Inglese con la votazione massima, nonostante ciò — sappiamo scrivere meglio? Sappiamo leggere meglio di come leggevamo e scrivevamo quattrocento anni fa quando non c’erano conferenze, quando non avevamo pensiero critico, quando non eravamo istruiti? La nostra letteratura georgiana è forse una toppa su quella elisabettiana?
A chi dobbiamo dare la colpa, allora? Non ai nostri professori; non ai nostri critici; non ai nostri scrittori; ma alle parole.
La colpa è delle parole. Sono le più selvagge, le più libere, le più irresponsabili, le più ineducabili fra tutte le cose. Invero potreste raccoglierle e ordinarle e piazzarle in ordine alfabetico nei dizionari. Ma le parole non vivono nei dizionari; vivono nella mente.
Se volete una prova, pensate a quanto spesso nei momenti di emozione, quando ne abbiamo più bisogno, non ci viene in mente nessuna parola. Eppure c’è ancora il dizionario; a nostra disposizione c’è qualcosa come mezzo milione di parole, tutte in ordine alfabetico.
Ma siamo in grado di usarle? No, perché le parole non vivono nei dizionari, vivono nella mente. Pensate di nuovo al dizionario. Lì, senza ombra di dubbio, ci sono opere ancora più splendide di Antonio e Cleopatra; le poesie appaiono più piacevoli dell’Ode a un Usignolo; romanzi come Orgoglio e Pregiudizio o David Copperfield sono i pasticci grezzi di qualche dilettante. È solo questione di trovare le parole giuste e metterle nel giusto ordine. Eppure non siamo in grado di farlo, perché esse non vivono nei dizionari; vivono nella mente.
E come vivono nella mente? In modo variegato e strano, così come le vite umane, andando di qua e di là, innamorandosi, e accoppiandosi insieme. È vero che sono molto meno vincolate da cerimonie e convenzioni, a differenza nostra. Le parole altisonanti si uniscono a quelle comuni. Le parole inglesi sposano le parole francesi, tedesche, indiane, africane, se hanno un po’ di fantasia. Ma per il buon nome della nostra cara Madre Inglese, è meglio se indaghiamo meno nel passato di questa signora. Perché, bella fanciulla peregrina, se n’è andata a spasso per il mondo!
È perciò peggio che inutile stabilire delle leggi per queste irrecuperabili vagabonde. Al massimo potremmo imporgli sparute, piccole regole di grammatica e ortografia. Tutto ciò che potremmo dire su di esse, mentre le scrutiamo oltre il confine di quella caverna profonda, oscura e a malapena illuminata in cui risiedono — la mente —, tutto ciò che potremmo dire su di esse è che sembrano gradire che le persone pensino e sentano, ma non che pensino e sentano a loro, ma a qualcosa di diverso.
Le parole sono altamente sensibili, facilmente intimidite. Non gradiscono che la loro purezza, o la loro impurezza, sia messa in discussione.
Se apriste una Società per l’Inglese Puro, loro dimostrerebbero il proprio risentimento aprendone un’altra per l’Inglese Impuro — di qui la violenza innaturale di gran parte del linguaggio moderno; si tratta di una protesta contro i puritani. Esse sono inoltre molto democratiche; pensano che una parola valga quanto un’altra; le parole incolte valgono quanto quelle colte, le parole non lavorate valgono quanto quelle lavorate, nella loro società non esistono ranghi o titoli.
Né gli piace che siano sollevate sulla punta di una penna ed analizzate separatamente. Stanno insieme, nelle frasi, nei paragrafi, talvolta per intere pagine allo stesso tempo. Detestano essere inutili; detestano fare soldi; detestano che ci siano conferenze pubbliche su di esse. In breve, detestano qualsiasi cosa le etichetti con un unico significato o le confini ad una sola attitudine, poiché cambiare è nella loro natura.
È forse questa la loro particolarità più sorprendente — la loro necessità di cambiare. Forse è perché la verità che cercano di afferrare è multiforme, e la esprimono essendo multiformi esse stesse, sfrecciando in questo modo, e poi in quell’altro. Per questo motivo per una persona le parole significano una cosa, e un’altra cosa per un’altra persona; sono inintelligibili per una generazione, e dirette come una picca per la generazione successiva. Ed è per questa loro complessità che sopravvivono.
Forse un motivo per cui oggi non abbiamo un grande poeta, romanziere o critico, dunque, è che noi rifiutiamo le parole nella loro libertà. Le fissiamo in un solo significato, il loro inutile significato, il significato che ci fa prendere il treno, il significato che ci fa passare l’esame. E quando le parole vengono fissate, piegano le loro ali e muoiono.
Infine, e nel modo più enfatico possibile, le parole, come noi stessi, hanno bisogno di riservatezza per vivere a loro agio. Senza dubbio gradiscono se ragioniamo, e gradiscono che le sentiamo, prima di utilizzarle; ma a loro piacerebbe anche che noi ci fermassimo; che diventassimo più inconsapevoli. La nostra inconsapevolezza è la loro riservatezza; la nostra oscurità è la loro luce… Quella pausa è stata fatta, quel velo d’oscurità è stato calato per far sì che le parole si uniscano in uno di quei veloci matrimoni, i quali sono perfette immagini e creano il bello eterno. Ma no — nulla di simile accadrà stanotte. Sono arrabbiate, le disgraziatelle; impertinenti; disobbedienti; stupide. Che stanno borbottando? «Tempo scaduto! Silenzio!».