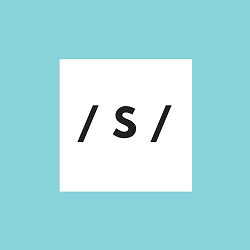«Facciamo che io ero» è la frase – quasi una formula magica – con cui i bambini cominciano i loro giochi
Nel raccontarvi la storia di Henrik e Konrad, vorrei che, come permette la magia della letteratura, mi seguiste nel gioco dell’immaginazione. Facciamo che noi siamo nel salone di casa nostra, in attesa. Nella stanza la tavola è imbandita, ogni pietanza e ogni fiore dentro il vaso sembra aspettino con noi un’epifania. Solo il fuoco che arde nel caminetto, consumando i ceppi con fiamme nere e rossastre, sembra essere vivo. Chi aspettiamo? Date la vostra risposta, prima di proseguire: chi aspettate, torturandovi le mani e i pensieri nell’attesa, confortati soltanto dal calore del vostro camino?

Ognuno di noi, ne sono sicura, visualizza un volto nella sua mente. Henrik aspetta Konrad. Aspettiamo un amico, dunque. Non un amico qualsiasi: è l’amico fraterno, con cui siamo cresciuti «come gemelli nell’utero materno»; con lui abbiamo condiviso sogni, speranze, dolore, noia, notti, fantasmi, e il flusso quotidiano delle nostre vite. Chi di noi non ha mai avuto un amico così? Focalizziamo nella mente e nello stomaco la sensazione fisica e irrequieta che ci dà la sua attesa. Lo abbiamo invitato a cena, e adesso lo aspettiamo. Questo nostro amico – che, come abbiamo detto, per noi è stato tutto – non lo vediamo da quarantuno anni. Siete rimasti interdetti? Ma com’è possibile – vi chiederete – che un amico così intimo e caro sia stato lontano da noi per tutto questo tempo? È stato malato, in guerra, rapito, disperso?
Il luogo in cui ha vissuto, in questi quarantun anni, lo conosciamo, a grandi linee: l’Estremo Oriente. Ma non è questo quello che davvero conta. Ciò che conta è la motivazione che lo ha spinto a partire, un giorno di quarantuno anni fa, che lo ha spinto a scomparire per sempre dalla nostra vita, recidendo quel cordone ombelicale che ha reso la nostra carne e la sua una cosa sola per tutta la nostra giovinezza. È la motivazione, ad esserci ignota.
Quando sarà nuovamente al nostro fianco, quando ci guarderà negli occhi che non abbiamo mai dimenticato, pur segnati profondamente dalle stesse rughe che segnano i nostri, il fuoco che fa scoppiettare le braci di questo camino, mentre fuori dalle portefinestre impazza una tempesta, lo illuminerà con la luce della verità? Un segreto esiste tra di noi, lo sappiamo bene, e ci ha separati. Un segreto cui è legata indissolubilmente anche un’altra persona che abbiamo amato e poi perduto. Quante volte, in questi quarantuno anni, abbiamo sospettato, temuto, intuito, respinto, desiderato di essere arrivati alla verità? Abbiamo costruito nella nostra mente un tribunale senza inquisito: lo abbiamo interrogato senza che lui potesse risponderci; lo abbiamo graziato, a volte, lo abbiamo condannato, quasi sempre. File di testimonianze, indizi, prove, ricordi, sono passati al vaglio della nostra giuria.
Adesso tutto questo può trovare una risposta. Abbiamo sempre pensato che la verità fosse disarmante, inoppugnabile. La verità è chiara, e si oppone alla menzogna, come il calore di questo camino si oppone al gelo da cui ci separano le finestre del salone, come il bianco si oppone al nero. Ma è davvero così? Cosa è la verità del fuoco in confronto ai quarantuno anni che abbiamo vissuto interrogando le sue ceneri? Quarantuno anni di fronte a delle braci che abbiamo guardato, toccato, odorato, maledetto, protetto, conservato, perché in fin dei conti erano la prova che qualcosa è stato: le braci non ci possono raccontare altro se non questo: il fuoco è esistito. Nient’altro. Se vorrete interrogare Konrad, un’ultima volta (perché siamo certi del fatto che il nostro amico non lo rivedremo; in fondo, era il segreto che esisteva tra di noi a permetterci di restare in vita a nostra volta, fino al giorno in cui ci saremmo rivisti) arrivate all’ultima pagina de «Le Braci» di Sándor Márai.