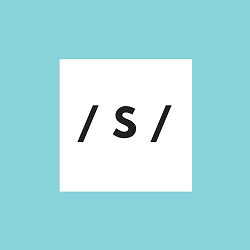Io, che alla fine mio figlio si è ammazzato. Si è ammazzato.
Da vivo ho fatto finta che era un uomo sano, il più sano fra tutti. Da morto ho sbattuto i piedi, le mani sul volto, ho cercato di rianimarlo con i miei sbattimenti. Col nero del lutto ho cercato di conservarne memoria. Chiunque m’incontra per strada sa che ho un figlio morto. Io, che alla fine mio figlio lo voglio curare. Prima che muoia. O moriva il padre o moriva il figlio. Il padre non l’ho partorito io, il figlio sì. Che muoia il padre. Alla fine noi femmine, noi genitrici, siamo le ultime a vedere la luce del sole. La vediamo quando muoiono i nostri carnefici. Che poi essere vittime alla fine era la nostra età d’oro. Io, che alla fine quel cazzo in bocca, alla fine, sono stata io ad infilarglielo. Da morto. Prima l’ho ucciso, poi gliel’ho fatto succhiare. Ho trasformato mia figlia in un’assassina. Ma la bambina, la bambina non la doveva toccare. Nel folto del bosco il peso morto ha lasciato la sua traccia. Anche da morto siamo le sue puttane. Anche da morto ci deve far lavorare. Mi sono rotta la schiena. Occultamento di cadavere. Io, che alla fine mio marito ha ammazzato solo un bambino. Che vuoi che sia? Io, sono io che mi sono cresciuta cinque figli da sola. E adesso gli viene in mente di mettermi incinta di nuovo. Io, sono io che mi butto nel pozzo. Quest’altro peso non lo voglio. Nel pozzo, nel pozzo troverò pace. Ritorno all’acqua. Il mio elemento. La terra, la terra è troppo pesante.

Io, che alla fine mio padre mi ha negato solo l’istruzione e la parola. Mi voleva far vivere in pace, senza troppe aspirazioni e pretese. Quando dalla vita non pretendi nulla, è in quel momento che trovi l’equilibrio. Il mio mondo finiva là dove la creta scalancava. Là dove l’argilla non riusciva più a trattenere l’acqua. Un giorno la pioggia era talmente fitta che si fece più pesante della terra. E quella casa circondata da masse di creta iniziò a muoversi. Tutti morti, ingoiati dalla creta. No, no alla fine sarebbe potuta andare così, ma siamo sopravvissuti tutti. Siamo ritornati tutti alla vita di prima, alla vita senza parola. Mi sono spostata, ho fatto quattro cose che alla fine mi hanno resa orgogliosa. Ho fatto un buon lavoro anche senza parola. Ma avrei preferito la parola al mio buon lavoro. E allora quello che non ho potuto fare io, quello che mi è stato negato da bambina, è diventato l’obiettivo di altri. L’universo è una grande massa lievitata. Ecco perché mi dà gioia vederlo riprodotto in piccolo mentre impasto la farina, con l’acqua, con il lievito. Lascio riposare, copro, aspetto che cresca con il calore del plaid. Copro e mentre lei cresce io vado a recitare il rosario nella casa di qualche morto. Alla fine, una parola si trova, anche se te l’hanno negata. La parola della preghiera, la parola della fede.
Mi sono scavata il mio tempio nella creta. Potevo morire ingoiata dalla creta, potevo morire cieca, potevo morire ammazzata e invece ho scavato. Scavato. Scavato. Scavando sono giunta sull’orlo di uno strapiombo. Era solo un orlo e io dovevo stare in equilibrio. Un orlo ben ricamato. Aveva delle alture, dopo una lunga salita c’era per forza una lunga discesa. Camminare su quell’orlo mi dava un senso di disperazione, una sensazione acuta come se lo stomaco fosse trafitto da un macigno di ghiaccio appuntito. Quell’orlo era solo orizzonte, non aveva alcuno spessore, alcuna profondità. Si perdeva nella nebbia dell’alba invernale. Zac zac zac. Dritto e rovescio. Zac zac zac. Non ne potevo più. Il mio stomaco la mia vescica il mio fegato, ogni passo in avanti, ogni passo indietro e i miei organi si spappolavano. Il cuore pompava ancora quando all’improvviso esplose come una stella caduta all’orizzonte. L’ eco doppia mi spaventò così tanto che le budella si svuotarono velocemente. Il cervello sembrava essere l’unico organo ancora intatto, protetto dalla scatola cranica. All’improvviso una nube bluastra si posò sulla mia testa e tramutò in polvere turchese il mio cranio.

Ormai non ero altro che un liquido, ancora viscido e denso, un liquido vaginale color fata turchina che si adattava a quell’orlo regolare. Un liquido che non aveva niente di umano. La mia forma attuale era ancora in grado di udire, vedere, toccare, forse anche addirittura pensare. Immaginare non so. Forse le immagini non riuscivano a rientrare in quella forma fluida. L’immagine è solida, congelata nello spazio. Impossibile immaginare in quella forma in fuga. Come le fughe del pavimento si adattava alle lacune che lo spazio le lasciava. Alle fratture interpersonali. Ma no, non erano lacune interpersonali quello era un deserto vuoto. In qualche lingua deserto e vuoto hanno la stessa etimologia, sono facilmente confondibili per lo straniero. Ma il deserto non è vuoto. Il deserto ha la sabbia, ha le oasi, ha i cammelli e i beduini. È pieno di sabbia, è pieno di mille granuli di sabbia. Il deserto non è vuoto. L’etimologia non ha sempre ragione. L’etimologia mi sembra quella strada ovvia che ci porta ad imboccare il sentiero sbagliato, il sentiero evidente che ci allontana dalla meta. Il sentiero che il lupo indica a Cappuccetto Rosso. Il mio orlo era il sentiero più ovvio, ma salvifico? Boh. Se il lupo non avesse indicato la strada fallace a Cappuccetto Rosso, la fiaba non potrebbe esistere. La salvazione. Di nonna e nipotina.
Su questo orlo giaccio spappolata. Aspetto la manna dal cielo. Aspetto che la volta celeste cada e mi schiacci. Che la volta celeste mi sia lieve. Cadi. Cazzo, strapiomba. Per te è semplice. Cielo e terra siete nati da un’esplosione alla fine. Adesso riunitevi. Riunitevi in un tornio che schiaccia questa massa viscida. Arriva un piccolo ratto di fogna spelacchiato, brutto come la morte. Cieco come una talpa, ha degli occhiali spessi e un cervello fine. Mi offre una scala a pioli. Una scala a pioli a doppia elica. La lascia vicino alla mia massa melmosa. Rovista nella sua sacca da pastorello del presepe. Tira fuori una pallina di piombo. Mi tappo le orecchie. Non so alla fine non ho più le orecchie, ma mi vedo che mi tappo le orecchie. Ho paura che quella pallina di piombo stia per fare un rumore assordante. La getta a terra. Che poi la terra su questo orlo strapiombo non c’è. Non so, non so più parlare. Lancia la pallina di piombo e questa si trasforma in un trono regale. Il ratto non riuscirà mai a sedersi su quel trono regale. È troppo alto per lui. Prova ad arrampicarsi e cade per tre volte. Dopo la terza caduta stizzito tira fuori dalla borsa un panno di lattice, spolvera l’orlo immacolato e si siede incrociando le gambe. L’ombra del trono bidimensionale cade dritta sul piccolo ratto. Io non so se possiedo ancora la voce. Provo a parlare, ma emetto solo suoni afoni. Mi agito convulsamente, ho bisogno di chiedere a quel ratto schifoso la direzione. Ma lui mi ignora, chiude gli occhi e inizia a meditare all’ombra del trono. Finita la meditazione si alza e si allontana in direzione opposta borbottando qualcosa. Mi lascia di nuovo da sola con la scala a pioli a doppia elica. Non ho più gambe né piedi. Mani e pollici opponibili sono cose dell’altro mondo. Come potrò salvarmi? Un falco ecco arriva un falco reale con il becco a uncino. Recupera la scala a pioli a doppia elica e la sistema in modo che io possa arrampicarmi sul trono. Con la mia voce afona invano cerco di spiegare al falco che non ho né mani e né piedi non potrò mai arrampicarmi su quel trono. Continuo ad agitarmi.
Quello che rimane del mio petto si frantuma ulteriormente in spasmi regolari. Ogni tre secondi si apre una frattura nel mio ex torace. Mi calmo. Sento cadere sul mio ventre gocce gelate. Inizia a nevicare. Finalmente anche le mie orecchie trovano pace nel silenzio ovattato. Sento un cinguettio in lontananza. Mi disturba. Nella luce abbagliante della coltre nevosa intravedo una macchia rossa. Un pettirosso, nel becco ha un chicco di grano. Individua in quella massa gelatinosa la mia cavità orale. Mi civa. Mi imbocca. Lascia cadere fra la fessura delle mie labbra il suo unico chicco d’oro. Non ho più nessun apparato digerente quindi il seme rimane intatto nella mia massa viscida e turchese. Il pettirosso mi solleva, come se fossi una stoffa d’organza. Delicatamente poggia le sue grinfie sulla mia massa gelatinosa che all’improvviso si trasforma in una trama leggera e trasparente. Mi solleva, attraversiamo il turbine della scala a pioli a doppia elica. Ho paura. Temo che questo piccolo uccellino di necessità da un momento all’altro mi lasci cadere giù nello strapiombo. Non ce la farà mai. Chiudo gli occhi forte forte e aggrotto la fronte così intensamente che sicuramente queste rughe mi segneranno in eterno. Finalmente arrivo in cima, ma non posso sedermi sul trono, non ho più il sedere. Provo a dimenarmi, vorrei esprimere una parola di gratitudine verso il pettirosso. Almeno un gesto.
L’uccellino mi capisce al volo, strizza l’occhio desto e vola via cinguettando. Sul trono c’è uno scrigno. Appena immagino lo scrigno aperto questo magicamente si apre. Nell’interno di velluto rosso vedo un papiro ripiegato su sé stesso. Chiudo di nuovo gli occhi forte forte e immagino di leggerne il contenuto. Il papiro magicamente si dispiega, emettendo un luccichio rosa da cartone animato della Disney, mi mostra il suo contenuto. Si tratta di una mappa con ventiquattro capanne di idrogeno e quattro cartelli stradali con quattro lettere stampate a caratteri cubitali ATGC. Non riesco a rimanere ferma sul trono. Ho appena il tempo di risucchiare al mio interno scrigno e mappa e vengo risucchiata a mia volta dalla doppia elica. È una sensazione che si vive solo negli incubi, quando la terra si sgretola sotto i tuoi piedi e un’elica ti soffoca nella sua trama. La cosa insopportabile è la coscienza di essere in un universo reale. L’incubo è un segmento temporale, la realtà è una retta i cui confini sono indefiniti come la mia massa. Chiudo di nuovo gli occhi forte forte. Prima o poi dovrò cadere. Prima o poi questa elica mi lascerà atterrare da qualche parte.
Scendo, scendo velocemente verso il basso trainata dal vortice del filamento a doppia elica. Come se al fondo di quella scala a pioli ci fosse un’aspirapolvere gigantesca pronta a risucchiarmi. Mi pare di udire i versi del risucchio, mi pare di udire un orco gigante pronto a risucchiarmi dalla sua cannuccia di bambù. In un giorno di pioggia sottile un uomo mi ha fotografata. Ero seduta ai piedi di un grade albero. A gambe incrociate poggiavo lo sguardo sulle acque placide e il sedere sulle radici del grande platano. Nel platano vivevano milioni di animaletti fantastici. Lavoratori instancabili, costruivano oggetti minuscoli dalla mattina alla sera senza sosta. All’interno del platano il tempo non esisteva, era sempre buio. Ma agli animaletti fantastici non serviva la luce perché loro erano ciechi. Facevano a gara a chi riusciva a costruire con più minuzia gli oggetti più inutili al mondo e alla comunità di animaletti fantastici. Nella foto si vedeva solo il cappuccio arancione del mio impermeabile verde. Nessuna traccia del mio volto. Il platano mi copriva dalla testa ai piedi, al suo fianco sembravo una figura minuscola e insignificante. Quell’ albero era il mio destino, la mia genia, sotto e sopra di me. Pervasiva. E io ne calpestavo le radici. Il vortice a doppia elica della scala a pioli lascia intravedere finalmente una luce. Una luce scura, una luce che sa di terra bagnata. Forse è il momento di atterrare. Morirò schiantata, non ho nessuna protezione. Chiudo di nuovo gli occhi e cado in un sonno profondo.
Al mio risveglio il sole sta già tramontando. Sento l’eco delle parole di mia sorella: «noi non possiamo mai essere una famiglia normale, no? Una cosa normale non riusciamo mai a farla, no?» Mentre mi pone quella solita domanda retorica sbatte forte il piede sinistro a terra come se volesse opporsi a quell’anormalità cronica. Io sento quello sbattimento, ma mi trovo sotto di lei, non più a fianco. La terra che lei ha appena calpestato è il cielo che trema sopra di me come un tuono. Sono caduta in un mondo sotterraneo e cavernoso. Umido, che sa di terra bagnata. Ne assaggio un po’, giusto per ricordarmi il sapore e il rumore che fanno i minuscoli grani di terra in bocca. Buona questa terra, rossa al punto giusto. È una terra che non ha mai visto i raggi del sole, una terra ombrosa e scura. Penso che non sia una terra di passaggio, nessuno passerebbe mai da questo luogo. Non vi sono grosse arterie che la collegano ai grandi centri urbani. È periferica e nascosta, anche rispetto al sole. Passa una signora vestita di stracci e come se mi leggesse nel pensiero urla con la sua voce rauca «il sole è per tutti». In testa ha un fazzoletto color cammello, tre cappotti infilati uno sull’altro, ha un bastone di legno e una sciarpa bordeaux. Si gira di nuovo verso di me e mi mostra il volto rugoso e peloso. A quella visione inizio a tremare: la mia massa, ancora gelatinosa, si muove facendo brevi sussulti. «Mi chiamo Filumena, porto tre cappotti, mi proteggono dal vento e dal fuoco. Sono una donna alla moda ed elegante». Si avvicina al bidone dell’immondizia e inizia a frugare. «Il tuo è il bidone più lontano perché stai su alla Pita, guagninè vien qua, vien a nonna» E con un gesto della mano mi fa un cenno. Ma non è mia nonna. Non la riconosco e tremo, tremo di paura. Sembra che il mio tremore sia l’unica sua fonte di gioia, scoppia a ridere in maniera fragorosa e fastidiosa. Si avvicina ancora di più e sento chiaramente un’insopportabile puzza di piscio, tipico delle vecchie incontinenti. «Guagninè, io vengo dal capo di basso, e tu a chi sì figlia? Vivo in una casa bella, di mattoni e travi. C’è tutto in casa mia. Quando vuoi vieni, vienimi a trovare. Solo il fuoco, solo non mi portare fuoco. Il fuoco a casa mia c’è già.» Dietro di lei compare un cane bianco, sporco di grasso. Le si avvicina con una reverenza signorile, poggia il suo muso sporco sul palmo della mano di Filumena per elemosinare una carezza. «Tre fratelli avevo, tutti all’America sono andati. Io, io non l’ho voluta lasciare la casa mia.» Fa uno starnuto e il muco giallo e catarroso, rimasto penzolante dal naso, lo risucchia con la lingua. «All’improvviso il fuoco s’è mangiato galline e pollastri. Travi e mattoni. Pure il cruopo della capra s’è mangiato. Guagninè a vuoi na caramell?» Mi lancia una Rossana puzzolente e io che non mangio da giorni la ingoio voracemente come un cane randagio.