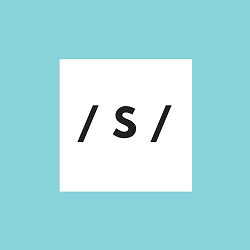Un racconto di Claudio O. Menafra

Il segreto della casata Von Lanzenstrauss
Capitolo I
Riferirò i fatti così come il destino li ha posti dinanzi alla mia fragile coscienza.
Nel modo in cui la mia mente a stento li ricorda, sperando che la loro rievocazione non scuota il sonno effimero e latente di quell’antico Male che ancora vigila sulla condotta della mia vita, pronto a stringerne i lacci e a soffocarne le ultime esalazioni.
Ai piedi di una gentile collina imbrunita ai fianchi da una selva crespa e indomata, si erge, dimentico dei tempi, l’antico feudo e dimora della mia stirpe, scomparsa anch’essa con la gloria del suo passato. Il vasto e decrepito latifondo segnato quasi naturalmente dalla fitta e strisciante foresta che ne corona i confini, era un tempo florido di pascoli e terre fertili, gravide di ogni meraviglia, ed era osservato in tutta la sua interezza dal remoto castello di Kaisersturm, situato ad est rispetto al possedimento e leggermente più in alto; nelle sue stanze decrepite, per secoli, i miei predecessori hanno vissuto e soggiornato compiacendosi della loro eredità.
Il castello di Kaisersturm era in origine circondato da alte e robuste mura merlate, di un rosso simile alle terre scarlatte d’Italia che, nei floridi tempi andati, formavano un perimetro di quadrangolo visibilmente irregolare, accompagnando le insenature e i dislivelli presenti alla base dell’antica collina, e rispettandone la conformazione; per chi fosse venuto da sud le mura sarebbero apparse simili alle onde increspate del mare del nord, balzane, incostanti, che non danno tregua alla mania tipicamente umana di rintracciare regolarità nelle forme della natura.
La cinta muraria, ridotta oggi a cumuli di melanconici ricordi cavallereschi, era scandita a sua volta, a grossi intervalli, da quattro torri gotiche i cui vertici sembravano ferire il cielo sanguinante durante le notti di tempesta, severe e iraconde strutture slanciate verso l’alto in grado di vegliare sulla tenuta. Da ognuna delle torri era possibile scorgere tutto il vasto spazio del circondario ed oltre, sino alla fitta foresta adiacente che pare oggi assaltare progressivamente l’imponenza delle mura.
Il mio nome è Hector von Lenzenstrauss e sono l’ultimo discendente diretto di un’antica casata feudale ormai sull’orlo del baratro e della decomposizione, a causa delle sorti segnate dalla moderna storia degli uomini, la quale ha deciso di privilegiare una moderna collettività sociale in cui il denaro decide le sorti degli individui molto più che il loro stesso valore e la loro discendenza.
Questo potente generatore di valori, dapprima eleva gli uomini sino alle vette aguzze della gloria e della fama, e poi li scaraventa nella polvere effimera dell’esistenza, cancellando le tracce del loro stesso passaggio su questa terra; la sua natura è tale da non essere posseduto, ma passa da individuo ad individuo, marcando il suo predominio tra gli uomini; spesso si sofferma e carezza per lungo tempo la fortuna di un suo fedele discepolo, ma alla sua morte ritorna all’antico compito, meretrice di molti uomini e ormai sovrano indiscusso della Storia.
Il nonno di mio padre, Johan von Lenzenstrauss, avendo previsto già in giovane età quale sarebbe stato l’inesorabile declino della nostra casata alla fine del secolo scorso, così come di ogni sua architettura rappresentativa, decise di trapiantare nel giardino che da sull’ingresso un enorme albero dalle foglie esili e aguzze, forse in cuor suo speranzoso che la vita potesse riuscire li dove la nuda pietra avrebbe fallito e cioè nello strenuo tentativo di arginare gli effetti deleteri del tempo cangiante e garantire eternità al ricordo; l’eterea pianta è ora il testimone forse più lugubre di questi tempi avversi dotata di una forma stregata e remissiva, oblunga e decadente utile solo a tenere alla larga qualche ladruncolo che fantastica sulle ricchezze segrete di una famiglia secolare.
Mio padre morì giovane, mentre mia madre fu presa dal sonno eterno il giorno stesso della mia nascita, così che fui allevato sin dalle fasce dal guardiano di corte, Winzler, il quale era già vecchio quando mi impartiva le prime lezioni di buon costume sociale e premeva affinché imparassi il latino. Solo in seguito scoprii che quelle lezioni di grammatica sarebbero state l’unica chiave di accesso alla sconfinata biblioteca esoterica nascosta nella parte sotterranea del castello, immediatamente sotto la torre ad ovest.
Nella mia prima gioventù Winzler mi ammoniva spesso quando stringevo legami amichevoli con i ragazzi del villaggio contiguo, i quali ai suoi occhi dovevano apparire dei poco di buono se il loro passatempo preferito consisteva nel gioco della palla, facendola rotolare a terra finché il fango non li avesse ricoperti da cima a fondo e, resi completamente irriconoscibili, se ne tornavano a casa lasciandomi solo davanti alle immagini confuse della mia coscienza.
In solitudine passavano quindi gli anni della mia prima giovinezza, ma la mia immaginazione era una compagna più che loquace e riusciva ad intrattenermi per ore creando capricciosamente forme e sagome di esseri chimerici e fantastici, a cui affidavo il compito di guidarmi nella scoperta di me stesso.
All’età di venticinque anni, Winzler si ammalò gravemente, la sua memoria cominciò presto a dare segni evidenti di instabilità.
Ancora oggi ricordo perfettamente il suo sguardo dilaniato dal tormento.
Quanto alle sue ultime parole, le ho ormai tragicamente rimosse.
Nonostante l’intralcio di un male sempre più incombente che lo privò lentamente di tutta la sua linfa vitale, della facoltà di pensiero e di favella, in un momento di lucida consapevolezza riuscì ad indicarmi il luogo preciso in cui, stando alle sue parole, era custodita da secoli una pergamena; mi spiegò che l’antico documento era stato regolarmente trasmesso di padre in figlio per tutta la durata della mia stirpe, e che me ne rivelava ora l’esistenza perché sentiva in cuor suo che la vita lo stava abbandonando e che forse quella sarebbe stata l’ultima occasione di trasmissione.
Mi fece giurare di non leggere il documento prima che avessi compiuto il trentesimo anno di età, e di non prendere neppure in considerazione l’idea di avvicinarmi alla biblioteca nel tentativo di sopire la mia curiosità. Perché proprio lì, nello scantinato immediatamente al di sotto della decrepita torre, si trovava la pergamena su cui era inciso il destino della mia stessa esistenza.
La morte di Winzler fece piombare le sale del castello in un diabolico e narcotico silenzio, in grado di stordire così a fondo il mio animo che le giornate passavano inesorabili e tutte uguali a loro stesse, tra i libri, le carte e i viaggi che ogni tanto intraprendevo per riunirmi con gli esponenti dell’alta società per affari, o semplicemente per non mandare in rovina le mie terre, alcune delle quali erano state di recente messe in vendita.
Per tutta la durata dei miei studi universitari il tempo mi scivolò dalle mani e la mia mente fu spesso distratta dal pensiero fugace di sbirciare tra le carte impolverate della mia famiglia. Passarono diversi anni e il ricordo di Winzler si tramutò nell’ennesimo ritratto che andò ad aggiungersi agli altri, nello sconfinato corridoio che attraversava il pian terreno del castello: sagome scheletriche di chissà quale conte o barone che condivideva parte del mio patrimonio genetico, tutte in splendide tenute di corte, con lunghi baffi e gote arrossate.
Riuscivo nei loro sguardi a scorgere qualcosa di tremendamente sinistro e familiare, e pareva mi fissassero attraverso il varco temporale della storia.
Fu in una di quelle notti inquiete che decisi di sapere.
Mi divincolavo nel letto, in preda all’eccitazione dell’immaginazione che, di notte, non è soggiogata dalle chiare luci della ragione.
Non riuscivo a prendere sonno, percepivo l’impellenza di dover fare un qualcosa di non chiaramente definito, ma non mi opposi. Mi feci coraggio e, dopo aver attraversato tutte le camere ed il corridoio di famiglia, scesi nello scantinato.
Le chiome brizzolate di enormi ragnatele sovrastavano gli angoli del soffitto, il quale seguiva le scale fino all’anticamera che portava alla biblioteca: qui erano accatastati tavoli di legno scricchiolante forati dalle tarme, erano accasciati su di un fianco, come vecchi gentiluomini affievoliti dal peso stesso della loro veneranda età.
L’ambiente era freddo, umido, propenso alla germinazione delle più strane creatura striscianti, e dappertutto nell’aere si respiravano gli odori pungenti degli organismi parassitari che si erano fatti strada lungo il perimetro della stanza.
Due portanti di legno indicavano severamente la porta successiva che avrebbe condotto alla dotta dimora.
Racconto di
Claudio O. Menafra