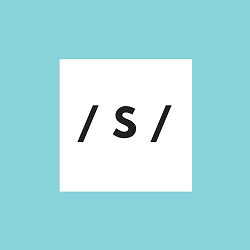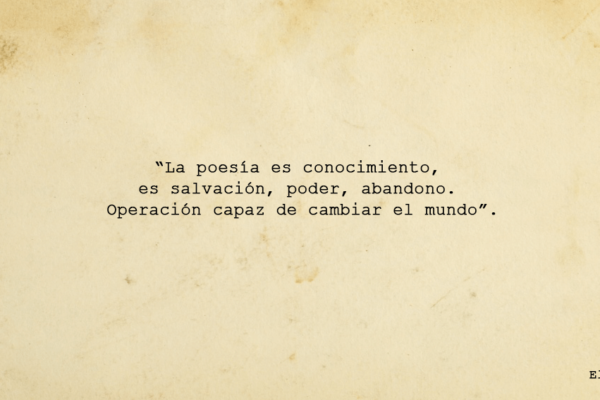Biografia dell’autore
Carlos de Oliveira nasce in Brasile, a Belém, nello stato di Pará, nel 1921 figlio di una forte immigrazione portoghese.
Tornerà in Portogallo due anni dopo nella regione della Gândara dove conoscerà e vivrà la grande povertà dei piccoli paesi portoghesi dei quali descriverà nelle sue opere le totali miserie e la totale impossibilità di uscire dalla propria condizione. Oliveira uno dei principali autori portoghesi del XX secolo, autore di romanzi come Finisterra, A casa na duna, di raccolte poetiche come Micropaisagem e di opere difficilmente classificabili come O aprendiz de feiticeiro, raccolta di cronache che altro non sono che il tentativo dell’autore di esprimere le proprie idee, il proprio vivere, con un tipo di scrittura che una delle più grandi studiose dell’universo lusitano, Giulia Lanciani, descrive come “ostinado rigor”.
L’ostinato rigore, l’ostinata ricerca delle giuste parole, sia per descrivere esattamente e con fedeltà il mondo intorno a lui, a partire da quell’ambiente “quase lunar”della Gândara fino alle cronache di fatti di vita, vissuti o immaginati, con la sua amata Angela, parte fondamentale anch’ella della sua produzione, in quanto revisionista delle sue opere e delle sue parole. Proprio il testo A viagem, presente nella raccolta O aprendiz de feiticeiro rappresenta perfettamente il legame con la moglie, con la brevità della vita e con la profondissima inquietudine che questa comporta. “Animula vagula blandula” sono infatti le parole che in fin di vita pronuncia l’imperatore Adriano, che ricollegano il poeta portoghese alla brevità delle cose e, soprattutto, alla forte inquietudine causata dalla vita.
La meticolosa ricerca delle parole, il continuo lavoro sul testo da parte dello scrittore, rende particolarmente difficile tradurre qualsiasi suo testo.
Importantissimo fattore, da non dimenticare, è che Oliveira scrive durante il periodo della dittatura salazarista. È possibile vedere infatti solamente un terzo del poeta, i restanti due terzi sono sommersi dall’acqua, nella famosa metafora dell’iceberg proposta dallo stesso scrittore. Di conseguenza è necessario saper cogliere il giusto significato delle parole di Oliveira, considerarle nel periodo in cui sono state scritte e riproporle in un’altra lingua senza snaturarle. Un’ ulteriore difficoltà è data dal fatto che nei testi dello scrittore spesso si fondono elementi reali ad elementi immaginari, lo spazio e il tempo non sono lineari, passato e presente si sovrappongono, in un universo in cui regna l’acronia.
Il viaggio
Dico le parole ad alta voce: “Animula, vagula, blandula”.
E le parole, sospese nel fumo della sigaretta, si soffermano un momento a pochi centimetri dalla bocca. Vedo il denso groviglio ondeggiare. Improvvisamente la velocità, i finestrini abbassati della macchina, lo colpiscono, lo disfano sulla mia spalla destra (guido con la testa leggermente volta a destra) e lo tirano indietro. Un colpo brusco. Le sillabe estese si schiariscono. La mia raucedine cede un po’. Penso io. Ciò che non cede è il terrore quasi superstizioso dello squarcio nella gola perché le sterzate continuano. Due o tre più forti devono bastare. La seta tenue si sta strappando…
Butto la sigaretta di fuori. Il mozzicone si frantuma nell’aria mossa dall’auto. Decine, centinaia di scintille colorano di rosso il lunotto e lo specchietto retrovisore.
Gelnaa dormicchia al mio lato e, come è solita fare, ha allacciato male la cintura di sicurezza, che le scivola dalla spalla. Spero che non mi senta parlare da solo e mi rimetto a provare la voce, ripeto il verso di Adriano:
“Animula, vagula, blandula”.
Stavolta il latino dell’imperatore fuoriesce più roco, senza che perda tuttavia tutta la dolcezza degli il, la musica alla quale gli aa aperti, alla fine, e il suono scuro e anteriore degli uu danno non so che tonalità contrastata, quasi misteriosa. Perché si tratta di un mistero, il turbamento che queste parole mi provocano da quando le lessi per la prima volta e la frequenza inaspettata con la quale le ricordo o dico involontariamente, soprattutto in quegli istanti che mi fa visita, ma che cosa? Come devo chiamare questa disperazione tranquilla, sentimento di piccolezza e impotenza, tenerezza insidiosa per le cose che è forse la maschera dell’autopietà, il gatto nascosto col culo di fuori?
Non so dove scoprii il verso. Ma poi, nella casualità delle letture, lo reincontrai qui e lì con lo stesso soprassalto. Mi ricordo di questo per esempio in una pagina di Aquilino. E ora? Localizzarlo nell’enorme opera? Sfogliai volumi e volumi: niente. Tuttavia è lì. In una di queste pagine più importanti che mettono nel fremito della vita il tocco di ciò che è precario, passeggero e allo stesso tempo coscienza di questa. Povera e piccola anima, luce di una candela che consuma la cera da quando nasce fino a quando si spegne.
Lo ho anche cercato, in primo piano, nelle “Mémoires d’Hadrien” di Marguerite Yourcenar, come titolo del primo capitolo e fiamma che accende tutto il libro, lunga e bella meditazione dell’imperatore che spiega a Marco Aurelio: “Ce matin, l’idée m’est venue pour la premiére fois que mon corps, ce fidèle compagnon, n’est qu’un monstre sournois que finira par dévorer son maitre”, per spegnere la luce.
E in Jorge da Sena nella “Peregrinatio ad loca infecta”, dove si dice che funse da topos “nel corso della letteratura occidentale, di ciò che divenne in Camões alma minha gentil, que te partiste.
In molti altri posti, certamente.
Ma il lavoro sotterraneo di questo verso non è solitario in me.
Altri versi, altre frasi mi divorano, pochi del resto, lavorano inoltre in modo oscuro per risalire di volta in volta in superficie. Avvisi, segnali di qualche codice Morse nebuloso ma importantissimo. Ancora due esempi. Da Alvaro de Campos: “ó companheira que eu não tenho nem quero ter”. Guardo Gelnaa e non comprendo. La ho e la voglio avere. Ma allo stesso tempo capisco: non dovrei averla o non vale la pena averla o allora mi duole la sua fragilità, ombra di un archetipo, eterno in questo momento. Subito dopo torno a non comprendere: il mio amore mortale, di carne ed ossa, ti ho per sempre, ora. Cose che si equivalgono, nella grammatica relativa della vita. Non ce ne hanno data un’altra, Geelna. E non appena finisco di pensare a questo, capisco nuovamente: nessuna compagna è possibile e le solitudini sommate pesano più di una sola. Etc.
Da Camões: “ A terna indiferença do mundo”. Inizia imbrunire intorno. La macchina, un punto mobile nel meridiano della strada che divide la terra in due parti rigorosamente uguali, apre, proprio lei, il solco di divisione, l’unico spazio dove possiamo passare e se ci fermassimo, l’universo di sinistra e quello di destra si distenderebbero nel catrame al loro incontro, bloccando il cammino, come due mari sassosi, con humus, acqua, insetti, alberi, il cataclisma lentissimo che miscela tutto nella stessa tenera indifferenza, perché la tenerezza è questo, mischiare, indifferenziare, e la indifferenzia (dal mondo), come dice anche la stessa parola.
Carico sull’acceleratore, cerco di aprire il solco finché posso, nonostante sappia che in questo o in quel modo il risultato, fatti tutti i conti, sarà identico, per non parlare della distanza in chilometri, ore, anni, tra la giunzione dei mari o ancora più in là.
Ma parliamo, certamente, non parliamo d’altronde d’altro, e per questo accelero.
Il motore risponde, la macchina fa una specie di salto in avanti che sveglia Gelnaa. Si raddrizza sul sedile, si allaccia meglio la cintura, alza il finestrino e rimane a guardare l’imbrunire.
Scivoliamo nel divario dei due universi. La strada è dritta e liscia. Centoventi, centotrenta. Nel paesaggio deserto, con il sole dietro, si perde la nozione di velocità. Il crinale della strada senza alberi, senza nulla, la luce obliqua, il tono purpureo della pietra, e molta più ombra del lato sinistro, nei monti coperti dalla vegetazione. Centoquaranta. Le cose si allontanano quando passiamo. Il mormorio del vento aiuta, il motore silenzioso aiuta, e la rapidità della macchina trasforma il cielo in un tunnel ancora chiaro ma più stretto in una ogiva di vetro, per dove bisogna passare esattamente altrimenti si spezza tutta questa architettura fragile. Centocinquanta, centosessanta. Allora la voce di Gelnaa, tranquilla e un po’ ironica, mi mette un principio di vertigine:
“Sai, un doppio suicidio è valido solo se entrambi sono d’accordo e tu non mi hai chiesto niente, no? “
Alzo il piede dall’acceleratore. L’aria si indurisce, rifluisce sopra il muso della macchina che vibra mentre la lancetta della velocità torna indietro e l’attrito della strada aumenta. Gelnaa si risistema un’altra volta, lascia stare la cintura, cerca le sigarette nella borsa. Anche a me andrebbe di fumare. Mi fa male la gola, le sterzate continuano, la voce sempre roca (quando è che la seta si strapperà?) ma non resisto:
“Una per me, accesa”.
Con i suoi gesti lenti, che la lentezza precisamente ritaglia e ammorbidisce, Gelnaa accende le sigarette nell’accendisigaro del cruscotto e me ne passa una.
traduzione di
Matteo Genova