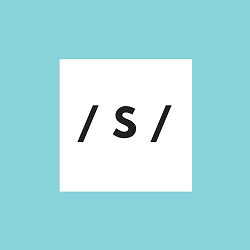L’incanto del bianco e del nero
Vi è mai capitato di svegliarvi in una qualunque mattina d’ inverno fredda e silenziosa, di un silenzio sordo? Assonnati allungate lo sguardo verso le imposte appena socchiuse e davanti a voi trovate il paesaggio brullo invernale vestito di nuovo, vestito di un manto bianco e soffice. La sera precedente siete sprofondati in un sonno pieno di ansie quotidiane, le ansie della famiglia, dello studio, del vostro status nella società, le solite ansie che scandiscono la vita dell’ uomo del “post”, del post–moderno e del post su facebook, che oggi è più story su instagram.

Niente è più degno d’ incanto e meraviglia, l’ infanzia è ormai passata e oggi si vive in fretta. Eppure quei fiocchi di neve ancora intatti, il biancore immacolato, reso nitido dalla luce dell’ aurora vi ha fatto brillare gli occhi, vi ha restituito il candore e la gioia dell’ infanzia perduta, del giorno di scuola saltato. Se questo incantevole sentimento, che lega il vostro sguardo puerile al vetro appannato della finestra, vi è già noto, non sarà difficile riconoscerlo nell’ultima pellicola di Paweł Pawlikowski. “Cold war”, l’ultimo film del regista polacco, dona allo spettatore uno spettacolo che ammalia con il suo bianco e nero, i suoi silenzi, interrotti dall’unico vero filo conduttore delle nitide diapositive che ci narrano una storia d’amore impossibile: la musica. Ci racconta la guerra fredda, quel periodo storico a noi tutti noto che i due protagonisti vivono come elemento esterno che determina i loro destini.
Ma più di tutto ci narra la guerra fredda che i due amanti vivono dentro i loro cuori
Cuori atrofizzati, che si amano ma non riescono a vivere insieme, non riescono a percorrere insieme il sentiero scosceso e abissale della quotidianità, da una parte o dall’altra della cortina di ferro.
Due cuoricini, quattro occhi/ piansero giorno e notte/ occhietti neri perché piangete, è impossibile incontrarvi/ incontrarvi è impossibile[1].
Così recita la prima quartina della canzone popolare polacca, che nel film si adatta ad ogni ritmo, ad ogni luogo, da Varsavia a Berlino a Parigi. Perché andiamo al cinema? Perché apriamo un romanzo? Perché ascoltiamo ancora una storia? Sempre e solo perché il mondo a colori non ci basta, non è sufficiente a placare la nostra inquietudine.
L’effetto straniante del bianco e nero, che rende le immagini così chiare e definite, della palma d’oro alla regia conferita a Paweł Pawlikowski, non può che trascinarci via dal mondo che resta fuori dal cinema. Sprofondiamo nella poltrona di velluto e rimaniamo affascinati, come ci affascina la fattucchiera di “quel paese lontano” che con i suoi occhi lucidi e nitidi ci toglie il malocchio. Un film che si sintetizza nella parola urok che in polacco ha una doppia valenza semantica, oscillante fra incanto e fascinazione.
Articolo di
Benedetta Cirone
[1] “Dwa serduszka cztery oczy łojojoj
Co płakały we dnie w nocy łojojoj
Czarne oczka co płaczecie, że się spotkać nie możecie
Że się spotkać nie możecie, łojojoj”
https://www.youtube.com/watch?v=6pzWffB0caM&authuser=0