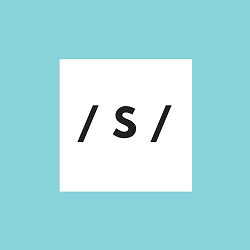La scalata sociale di due contadini tipicamente “romeni”
Vi ricordate quella canzone che andava tanto di moda al volgere del nuovo millennio? Cantata sul palco di top of the pops da una bionda con frangetta, tacchi a spillo, pantalone attillato e corpetto di pelle? “Haiducii Dragostea Din Tei”, a parole nostre la cantavamo tutti in Italia. Ecco con questa hit degli anni duemila si è concluso lo spettacolo teatrale “Gli sposi”, testo di David Lescot, interpretato e diretto dai due mitici attori Elvira Frosini e Daniele Timpano, andato in scena sotto le capriate lignee del Teatro India.
Palcoscenico vuoto, l’unica scenografia è data da giochi di luci e ombre e pochi oggetti portati in scena dagli attori stessi. Compariranno due sedie, due microfoni, una cravatta, un cane di plastica, labrador di razza pura “romena”. Ognuno di questi oggetti avrà un forte valore simbolico e designerà un momento di passaggio nella storia personale e pubblica dei coniugi Ciauşescu. I microfoni dai quali il signor Ciauşescu prenderà la parola nel partito, segnano la sua scalata verso i vertici della classe dirigente rumena del dopoguerra. In seguito entrato a far parte dell’ élite del partito indosserà la cravatta, ma non si spoglierà mai dei suoi abiti di contadino della Valacchia, regione più “romena” di tutte le regioni “romene”.
A noi di The Serendipity piace riflettere su questioni di natura squisitamente linguistica e allora ci siamo interrogati sul perché i due attori, di bravura eccezionale, capaci di mantenere viva l’ attenzione del pubblico per tuttala durata dello spettacolo, avessero scelto l’ aggettivo “romeno” e non il più diffuso e comune “rumeno”. E noi perché per strada sentiamo “rumeno” e non “romeno”? Secondo l’Accademia della Crusca questa è una questione che ha tenuto impegnati i linguisti per più di un secolo ormai. Le due varianti “romeno” e “rumeno” esistono anche nella lingua rumena. La questione non è solo di natura etimologica – “romeno” si rifà ad un etimologia più antica rispetto a “rumeno” – ma è legata alla storia sociale e politica della Romania. Le radici di questo problema risalgono al II secolo quando sotto la guida di Traiano l’impero romano conquista i territori della Dacia. Da questo momento in poi inizierà una commistione fra le popolazioni slave, che precedentemente abitavano quella regione, e i nuovi coloni romani, di stirpe latina. In seguito si stanzieranno nella Dacia altre etnie – ungheresi , tedeschi, slavi e rom. In questa commistione di popolazioni il termine “ruman” nel tempo va acquisendo una connotazione negativa, perché indicava, come afferma Luisa Valmarin in un saggio del 1989, non solo l’ appartenenza ad un’ etnia, ma anche la condizione sociale di servo della gleba. Durante l’800 si cerca di enfatizzare e riscoprire il legame dell’ etnia rumena con la stirpe dell’ antico impero romano. Perciò viene ripreso e rivalutato il termine “romeno” che esplicitava maggiormente il legame con la stirpe latina.
Quindi l’ autore e gli attori compiono una scelta lessicale ben precisa utilizzando il termine “romeno”, scelta lessicale che ha lo scopo di enfatizzare uno dei tratti peculiari della politica nazionalpopolare di Ciauşescu: l’ assioma del “tipicamente romeno”. Tutto ciò che è “romeno” è “popolare” e alla Romania non serve altro. Se importiamo una canzone dall’estero, la traduciamo in “romeno”. Difatti le versioni “romene” di Caterina Caselli e Raffaella Carrà hanno intervallato il battibeccare dei coniugi, scatenando l’ilarità del pubblico.
Ma se dobbiamo proprio dirlo, a dominare nella coppia Ciauşescu portata in scena al teatro India non è il Conducator della Romania, l’ efferato dittatore comunista che farà morire di fame il suo popolo, il popolo di cui egli si definisce figlio. A dominare nella coppia è la signora Ciauşescu. Lei correggerà la balbuzie del suo uomo, gli indicherà dove mettere gli oggetti sul palco, gli indicherà come muovere gli uomini di partito, come muoversi in ambiente internazionale, come ricoprire di marmo e oro il suo palazzo. Rappresenta la sua ombra, la sua fame di potere che logora il popolo rumeno, ridotto agli stenti. Lei con la sua laurea honoris causa in chimica caccia dalla tasca il suo smartphone, apre instagram e racconta al pubblico le innumerevoli barzellette su Ciauşescu, largamente diffuse in Romania fra la gente comune. Questo geniale espediente narrativo non solo ci racconta la realtà della società rumena negli anni della dittatura comunista, ma distrugge anche la maschera che i coniugi si costruiscono passo dopo passo grazie alla retorica del partito. La realtà sociale, la realtà rurale, gli operai, il popolo di cui si definiscono figli sono solo dei concetti ormai pieni di retorica, di echi.
Il cane del dittatore ha un cuoco e i lavoratori romeni non lavorano abbastanza, non producono quanto gli operai coreani. La figlia del dittatore pesa la carne sulla sua bilancia d’oro e le donne romene, le donne del popolo, devono produrre più figli. Il popolo romeno deve essere più numeroso degli zingari. Una delle peculiarità della dittatura di Ciauşescu, e non solo, fu proprio questo connubio insolubile fra comunismo e nazionalismo, in cui il “popolare” il “tipicamente romeno” viene strumentalizzato come arma contro le altre etnie presenti nel territorio o ai confini prossimi della nazione. Vecchia e usurata storia nella “polveriera dei Balcani”.
Ultima scena. Il processo. E i corpi dei condannati mai più trovati. E il cane labrador tipicamente “romeno” che secondo la leggenda popolare scappato dal palazzo di marmo dei Ciauşescu, si ferma e scava e ancora è alla ricerca dei corpi dei due contadini della Valacchia che forse hanno fatto troppa fortuna.
Tutto questo ci è stato solo narrato dai due attori, ma ogni spettatore è riuscito a ricostruire l’universo narrato in un palcoscenico senza scenografia. Raccontare una storia e raccontarla in un certo modo esercita ancora il suo potere evocativo sul pubblico e di questo siamo tutti felici e contenti.
Articolo di
Benedetta Cirone