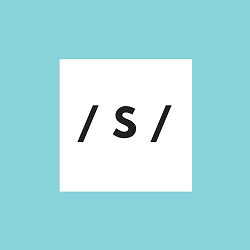Un articolo a cura di L’Ibis Scarlatto in cui ci si immerge nel cinema di Alice Rohrwacher
Dopo uno iato di quattro anni, Alice Rohrwacher, regista e sorella dell’attrice Alba, torna al cinema con un nuovo film. L’opera ripropone i temi fondamentali della cinematografia della regista, eppure manifestando più chiaramente un pessimismo, sinora solo accennato, ma costante della visione della sua autrice.
«Un premio non fa primavera» recitava qualche articolo dopo l’annuncio della vittoria de La Grande Bellezza agli Oscar, quattro anni or sono. Valutazione più che legittima, contando lo stato di pressoché totale apatia e mancanza di creatività in cui imperversa, ancora oggi, il cinema italiano. Tuttavia, se poi si ha la possibilità di vedere un film di Alice Rohrwacher, allora si può ben sperare per il futuro del nostro cinema. E la giuria del Festival di Cannes del 2014, presieduta da Jane Campion, ben comprendendo le potenzialità di una regista poco più che trentenne, aveva deciso di assegnarle il Grand Prix speciale della giuria. Mentre, quest’anno, con il nuovo film Lazzaro Felice, la Rohrwacher ha incassato il premio per la migliore sceneggiatura sempre al Festival di Cannes. Segno, questo, di un sempre crescente interesse e riconoscimento che la cinematografia soprattutto estera, ed europea, sta rivolgendo alla produzione di questa giovane cineasta.
A ogni modo, l’opera di Alice Rohrwacher ha radici antiche, affondando nel passato della sua creatrice, di cui riprende l’ambientazione “bucolica” oltre al crescente contrasto fra urbano e rurale, in un’ottica prima di tutto di maturazione dell’età. Alice nasce infatti a Fiesole, in Toscana, ma passa la propria infanzia nella provincia di Terni; il passo successivo della sua formazione artistica è la frequentazione dell’Università di Torino, dove consegue la laurea in Lettere Antiche. Il primo avvicinamento al cinema l’ha tramite il documentario, quando conosce il produttore Carlo Cresto-Dina e partecipa, nel 2006, all’opera collettiva Checosamanca, da lui prodotto. Ma tutto ciò è ancora soltanto un apprendistato. Il passo successivo della sua evoluzione è sempre indotto da Cresto-Dina, che le propone di scrivere qualcosa di proprio: così nasce Corpo Celeste (2011). «È stato lui a insistere perché provassi a scrivere qualcosa che, all’inizio, non si capiva se fosse una ricerca per un documentario all’interno delle parrocchie di Reggio Calabria oppure un film. Dopo aver raccolto tanto materiale ho pensato che non potevamo riprenderlo in forma di documentario, ma che dovevamo rimetterlo in scena», come ha dichiarato la regista in un’intervista rilasciata a CineCritica.
Il film, nonostante un’iniziale apparenza, ha non a caso davvero poco del documentario. Si pone in effetti ad un livello di visione più profondo, con il quale si abbandona l’obiettività propria del documentarista per tentare di scavare dentro una società emarginata, falsa e superficiale, come quella della periferia di Reggio Calabria, e coglierne tutte le contraddizioni. La protagonista è la piccola Marta, bambina tredicenne che, dopo aver trascorso dieci anni in Svizzera, ritorna con la famiglia a Reggio, la città in cui è nata. Qui entra, su insistenza della madre e della zia, in contatto con la comunità della parrocchia di quartiere, gestita da don Mario. In questa desolata periferia, dove regnano la povertà, i rifiuti e il disinteresse, l’unico reale centro di aggregazione è proprio la chiesa: i bambini la frequentano per potersi cresimare; gli adulti lo fanno più per abitudine che per una reale necessità di natura o aspirazione spirituale. Andare in chiesa infatti conta: per sentirsi parte integrante di un gruppo più ampio, solo apparentemente unito, di persone, e per contrastare la solitudine e l’isolamento che regnano nelle grandi città.

Marta però non è così. È una bambina riflessiva, insicura e che si isola facilmente. È una bambina dalle tante domande, che raramente trovano una risposta adeguata. È una bambina sull’orlo della pubertà, che vive nel modo più autentico e meravigliato il seno che man mano si sta formando e le prime mestruazioni. Ma, soprattutto, è una bambina alla ricerca dell’autenticità nei rapporti. Per questo la chiesa non può essere il suo posto, dal momento che i ragazzi che frequentano il catechismo sono tutto meno che interessati al messaggio che la catechista Santa tenta, con coraggiosa tenacia, di veicolare loro, anche per il tramite di formule o giochi che contrastano con il messaggio cristiano di fondo. Il catechismo diventa non più un luogo di incontro, confronto e maturazione nella fede, ma si appiattisce su una semplice somministrazione di nozioni infantili, di canzoncine imparate a memoria e di quiz alla Chi vuole essere milionario, per mezzo dei quali l’innocente e sprovveduta catechista tenta invano di interessare i ragazzi, intrisi di cultura televisiva.
Nella comunità parrocchiale regnano dunque l’apparenza e la differenza: l’interesse reale delle catechiste non è quello di riavvicinare la gente alla religione, bensì quello di riempire fisicamente la chiesa. La figura dello stesso parroco è emblematica di tutto ciò in quanto, del tutto disinteressato della sua comunità e della parrocchia, è unicamente spinto ad agire dalla remota possibilità di essere trasferito in una parrocchia dove possa essere più utile. È svogliato, stanco, recita a fatica le preghiere e le omelie. Non conduce la parrocchia, la amministra (ad esempio, riscuotendo l’affitto dell’appartamento locato alla famiglia di Marta) e fa il galoppino “politico”, cercando di ingraziarsi il vescovo che gli può garantire il trasferimento. In un’ambientazione in cui la vita comunitaria si cristallizza in formule rituali stereotipate e i rapporti umani appaiono quanto mai autistici, l’innocente Marta è destinata ad isolarsi e a cercare un contatto con gli emarginati (dall’anziano don Lorenzo ai giovani che si aggirano nelle discariche), quali detentori di quella purezza data solo da uno spirito non corrotto dalla materialità.
Perciò, alla fine Marta diserterà la cresima e, recatasi sotto un ponte nei pressi di alcuni rifiuti, si immergerà nell’acqua lì raccoltasi: solo così potrà purificarsi da quel mondo ipocrita nel quale non si è mai riconosciuta, e, attuando una catarsi, venire incontro alle uniche figure autentiche in una società di apparenza e formule recitate che non si sono realmente comprese. Nonostante sia un’opera prima, lo stile della Rohrwacher è già maturo: la macchina da presa è frenetica, tuttavia mai gratuitamente. Lo sguardo della regista si concentra, con istinto sicuro, su ciò che è realmente importante e «obbliga lo spettatore a prendere una posizione di fronte alle cose. Come fanno gli occhi di Marta» (Paolo Mereghetti), di cui restituisce le tensioni pubero-adolescenziali insieme alle sensazioni di quest’ultima, la comprensione di non essere accettata per come è e dell’inevitabilità dello scontro col mondo circostante pur di emergere. Il film di Alice Rohrwacher non è comunque un film anticlericale, è un film poetico, intimo, lirico. Il suo interesse non è tanto quello di rappresentare mondi reali, quanto piuttosto quello di raccontare le storie di figure isolate, dimenticate e che cercano in ogni modo di guadagnarsi la propria indipendenza, senza però negare le proprie natura fanciullesca e innocenza. Su questa scia si muove il secondo film della Rohrwacher, Le Meraviglie, uscito in sala nel 2014.

Il film, a chiaro sfondo autobiografico, racconta la vita di una famiglia di apicoltori toscani, formata da un padre tedesco, una madre italiana che parla francese (interpretata da Alba Rohrwacher) e quattro figlie, fra cui spicca la figura di Gelsomina, la maggiore e la capo famiglia. Il gruppo familiare conduce un’esistenza appartata, lontana dalle altre famiglie e dal mondo confusionario e corrotto delle città; le bambine trascorrono le giornate aiutando i genitori nella produzione e vendita del miele o inscenando balletti sulle note di T’appartengo di Ambra Angiolini. La loro è un’esistenza protetta dalle quattro mura di casa e dall’intransigente e burbero padre Wolfgang, tutto concentrato nell’utopia di preservare il suo piccolo Eden, fatto di campagna incontaminata, dall’invasione di forze esterne, quali i turisti e la tecnologia, che possano ledere quella vita “diversa”, che con tanta fatica ha costruito. Un mondo che, per la protagonista, si impernia sul rapporto fra sorelle, un legame fatto di spontaneità e amore profondo.
«E tu pur, siepe, immobile al confine, / tu parli; breve parli tu, ché, fuori, / dici un divieto acuto come spine» (Giovanni Pascoli).
Un giorno, la famiglia si imbatte nella pubblicizzazione di un concorso rivolto ai produttori locali e nel quale sono messi in palio dei soldi. Nonostante la disapprovazione del padre, quindi di nascosto da quest’ultimo, Gelsomina iscrive, la famiglia, sperando in una vincita che possa non solo consentire di migliorare sensibilmente le loro condizioni economiche, ma anche di abbandonare uno stile di vita che è diventato fin troppo stretto e limitante per delle bambine sulla soglia dell’età adulta. Gelsomina incarna proprio questo atteggiamento: sebbene tenti in ogni modo di compiacere il padre (in quanto a lui simile), è schiacciata dal desiderio di fuga, una fuga che la porterebbe ad avere quanto gli altri hanno in termini di possibilità di svago e socializzazione, e, in particolare, le consentirebbe definitivamente di accedere all’età adulta. Ciò è emblematicamente espresso da un amico del padre, il quale dice a Wolfgang: «Attenzione, questa figlia ti sfuggirà». Lo scontro con il possessivo padre è pertanto inevitabile, considerando in particolare che proprio la giovane Gelsomina interviene dove le figure genitoriali sono assenti o dove hanno fallito miseramente, come, ad esempio, nell’intessere un rapporto affettivo con Martin, il bambino tedesco condotto in famiglia per essere rieducato.
Lo scontro fra generazioni diventa quindi un tema centrale del film, dove da una parte c’è quella di Wolfgang, chiusa nelle proprie piccole cose, nei propri rituali e incapace alla comprensione, quasi maschilista a certi tratti (si comprende che il padre non ha mai realmente accettato che gli siano nate solo figlie femmine), e dall’altra, quella di Gelsomina, spensierata, speranzosa nel futuro, ma allo stesso tempo pienamente cosciente delle difficoltà del vivere. Gelsomina non vuole, infatti, essere come i suoi coetanei, superficiali e attirati solo dall’apparenza, vuole semplicemente sentirsi come loro, cioè condurre la propria adolescenza in serenità, senza che le siano addossate responsabilità che non si dovrebbero richiedere ad un’adolescente. Si ritrova anche qui, come in Corpo celeste, l’idea che la televisione realizzi un appiattimento etico-morale sulla complessità delle persone e, in questa chiave, va letto lo strenuo tentativo della testimonial Milly Catena (interpretata da Monica Bellucci) di avvicinarsi alle bambine, al fine di instaurare con loro un rapporto umano che le consenta di non rimanere imprigionata nella maschera che indossa. Lo stile della Rohrwacher si dimostra, ancora una volta, uno stile asciutto, intenso e soprattutto spontaneo, in grado di restituire, con tutta la sua forza poetica e lirica, la bellezza e la purezza della giovinezza. Tempo in cui le sue protagoniste sono sospese fra maturità e fanciullezza; uno stato, questo, che meglio di ogni altro è in grado di cogliere gli splendori e le disarmonie della realtà, restituita per come è filtrata dallo sguardo e dalle personalità delle sue eroine.

Sembra invece porsi a metà strada fra Le Meraviglie e Corpo Celeste, Lazzaro Felice, appunto l’ultimo film di Alice Rohrwacher. La vicenda ruota intorno alla tenuta della marchesa Alfonsina De Luna, proprietaria di appezzamenti di terreno coltivati a tabacco, presso i quali lavorano svariati contadini tenuti dalla stessa marchesa in un regime di mezzadria. Tuttavia, siamo a cavallo fra gli anni ‘90 e gli anni 2000 e i braccianti sono totalmente all’oscuro dei regimi salariali legali nonché dell’esistenza di determinati diritti che possono rivendicare. Fra di essi c’è Lazzaro, un giovinotto robusto ingenuo e bonaccione, da tutti utilizzato per svolgere determinate mansioni, in particolare quelle più gravose, data la sua incondizionata disponibilità. Il mondo de L’Inviolata (la tenuta si chiama così) è veramente un piccolo universo a sé stante: gli abitanti non lo possono lasciare senza il consenso della sua proprietaria; le nozioni di vita si imparano dal confronto con gli anziani; la giornata è scandita dai ritmi del lavoro nei campi. Il tutto si regge su un equilibrio, tanto stabile quanto precario, qual è quello di un mondo incorrotto dalla mondanità e dai beni materiali. E di questa innocenza Lazzaro medesimo diviene emblema: uno stato di grazia e serena accettazione della vita, dettata dalla presa d’atto di essere un granello di un meccanismo più grande, in cui gli egoismi lasciano spazio a una solidarietà di fondo che rende tutti partecipi delle esperienze altrui, e in cui però l’abnegazione si rivolge contro chi la profonde.
Una purezza, quella dei braccianti, che li rende quindi vittime del “grande inganno” orchestrato dalla marchesa che li tiene, a loro insaputa, in un regime di semischiavitù, senza alfabetizzazione e senza una effettiva retribuzione. Si tratta di uno stato di innocenza che è destinato ad infrangersi contro il mondo reale, nel quale i braccianti de L’Inviolata saranno presto reintegrati, dovendo, inevitabilmente e pur di sopravvivere, adottare quei comportamenti e quei valori di corruzione morale che reggono le città mondane. Ma, persino in questo nuovo contesto fatto di truffe, furti, invidie e noncuranza dell’altro, Lazzaro rimane sempre uguale a se stesso. Difatti, dopo essere precipitato da un burrone è dato da tutti per morto, ma in realtà (al pari del Lazzaro evangelico di cui porta il nome) si risveglia anni dopo senza essere mutato nell’aspetto o nell’età. Per puro caso reincontra alcuni dei suoi affetti, dall’ormai cresciuta Antonia, diventata una ladra, al figlio della marchesa Tancredi, nel pieno del fallimento economico. Come era ingenuo e innocente nel mondo contadino da cui proviene, così Lazzaro lo resta anche nel panorama plumbeo e grigio della periferia milanese. Non a caso, come ha avuto modo di chiarire la stessa regista, egli diviene il simbolo dell’immutabilità, l’elemento costante in un mondo di continuo fluire.
Il giovane non solo rappresenta, a livello umano, i sentimenti di bontà, gentilezza e armonia col mondo circostante, ma allo stesso tempo evidenzia come essi, nonostante tutto, perdurino negli animi anche se corrotti dalla materialità. Per quanto, dunque, la città porti corruzione nell’anima, negli animi degli ex abitanti de L’Inviolata rinverdiscono quei sentimenti di vivacità e spontaneità propri di un clima solidale e collettivo, non appena riaffiorano le memorie di quei luoghi. Tuttavia, per davvero poco tempo; ben presto la generosità lascia spazio all’egoismo e l’unica cosa che Lazzaro decide di fare è combattere per il bene di Tancredi la causa del suo “male”, risultando però vittima, sempre in forza della sua ingenuità, della violenza altrui. Uno sguardo così espressamente pessimista fa di conseguenza muovere Lazzaro Felice su binari diversi dai due film precedenti: da una parte, perché se in Corpo Celeste si era privilegiato lo sguardo sulla città, evidenziandone le contraddizioni, e ne Le Meraviglie l’attenzione era stata rivolta alla campagna, presentandone gli intrinseci limiti, ora la Rohrwacher pare creare una contrapposizione fra paesaggio urbano e rurale, dove il secondo prevale per la genuinità dei valori di cui è espressione mentre il primo è il luogo dei vizi e della povertà oltre che economica anche morale; dall’altra, perché se nei suoi primi due film aveva sempre parlato di vicende su cui si stagliavano figure sull’orlo dell’età adulta, perciò che crescono e si devono far strada in un mondo che loro si contrappone, con Lazzaro il mondo circostante continua, sì, a contrapporsi, ma il giovane non fa nessuno sforzo per affermarsi ed opporsi.
Dall’evoluzione all’immutabilità. Non può pertanto esservi successo in questa nuova visione dei rapporti; l’essere innocente, per quanto rimanga uguale, è destinato a soccombere sotto le forze di una società in continuo movimento, frenetica e il cui tempo non si adatta a quello della persona.  Allora, è solo tornando al mondo antico e dei valori puri (per cui, quello rurale) che è possibile effettuare la catarsi dai vizi. Una purificazione che non passa più per una maturazione, ma bensì per una riaffermazione di un universo che non c’è più, e da cui finiscono per essere inibiti tutti i tentativi di fuga. Tentativi non più necessari se la società tecnologica esaspera le disuguaglianze, mentre la campagna con la sua natura, sebbene perpetui lo sfruttamento reciproco (secondo la marchesa De Luna, come Lazzaro è sfruttato dai suoi simili, anche lui sfrutta qualcun altro: perché è nella natura delle cose), ciò avviene mantenendo la spensieratezza del vissuto. Col male minore per l’uomo. Il cinema di Alice Rohrwacher è un cinema fatto di piccoli momenti e grandi personaggi; è un cinema umano, povero nei mezzi, ma ricchissimo nel messaggio e nella poeticità. È un cinema del corpo, della persona e per la persona.
Allora, è solo tornando al mondo antico e dei valori puri (per cui, quello rurale) che è possibile effettuare la catarsi dai vizi. Una purificazione che non passa più per una maturazione, ma bensì per una riaffermazione di un universo che non c’è più, e da cui finiscono per essere inibiti tutti i tentativi di fuga. Tentativi non più necessari se la società tecnologica esaspera le disuguaglianze, mentre la campagna con la sua natura, sebbene perpetui lo sfruttamento reciproco (secondo la marchesa De Luna, come Lazzaro è sfruttato dai suoi simili, anche lui sfrutta qualcun altro: perché è nella natura delle cose), ciò avviene mantenendo la spensieratezza del vissuto. Col male minore per l’uomo. Il cinema di Alice Rohrwacher è un cinema fatto di piccoli momenti e grandi personaggi; è un cinema umano, povero nei mezzi, ma ricchissimo nel messaggio e nella poeticità. È un cinema del corpo, della persona e per la persona.
«Il film dovrebbe essere un corpo a corpo. Ho escluso tutti gli altri tipi di combattimento, ed è rimasto solo quello».
Articolo di
Luca Zammito