La semantica storica di un’etichetta di valore
Il panorama idiomatico della nostra penisola italiana si presenta come un immenso mosaico lussureggiante e rigoglioso le cui componenti sono rappresentate dalle diverse manifestazioni dialettali sedimentatesi diacronicamente all’interno di precisi contesti territoriali d’appartenenza, e che fronteggiano a viso aperto la monolitica unificazione nazionale e linguistica avvenuta in quel fatidico 1861, anno in cui la Repubblica Italiana esce finalmente, almeno da un punto di vista formale ed istituzionale, dal macigno del particolarismo politico che perdurava ormai da secoli.
Da un lato, quindi, l’unità nazionale ed identitaria rappresentata
da quello che viene accademicamente denominato italiano standard, stipulatasi definitivamente a partire dal lento ed inesorabile processo di unificazione linguistica che va di pari passo con l’unificazione politico-nazionale; dall’altra, invece, un ribollire convulso di lingue, parlate e sistemi di significazione sedimentati all’interno di precise circoscrizioni diatopiche, vale a dire territoriali, che forniscono un contraccolpo culturale ed espressivo di non poco conto da un punto di vista strettamente linguistico, essendo in grado, cioè, di instaurare un vero e proprio rapporto di reciproca influenza con la parlata nazionale.
Un dato numerico può indicarci
sin da subito la straordinaria complessità culturale ed espressiva presente all’interno del nostro territorio: l’Italia è formata da ben oltre settemila comuni[1], la maggior parte dei quali spesso ricopre una superficie davvero irrisoria con una demografia che va poco al di là del concetto di famiglia allargata[2]; molti di questi agglomerati semi-urbani, spesso antichi, in aggiunta, si presentano divisi a loro volta in diverse frazioni; ognuna di esse con un proprio sistema di codificazione dialettale. L’Italia viene consacrata, quindi, quale uno dei Paesi europei più ricchi e differenziati dal punto di vista della varietà della lingua. Non si tratta ovviamente di un semplice fatto di quantità, alla questione numerica va aggiunta la componente qualitativa, e cioè la differenza ontologica e filogenetica delle varie parlate dialettali italiche, spesso così lontane tra di loro da far scadere in secondo piano la loro contiguità geografica; le nostre parlate dialettali non sono solo tante, ma anche profondamente differenziate strutturalmente[3]; la distanza linguistica non ha nulla a che vedere con la distanza geo-culturale (gli esempi sono molteplici, così accade ad esempio tra Bologna e Firenze, Roma e Tivoli).
Per definizione una lingua storico-naturale
è la categoria suprema attraverso la quale l’essere umano passa in rassegna i dati empirici racimolati dalla sua esperienza senziente, la struttura organizzativa del mondo fenomenico e noumenico, lo strumento mediante il quale significhiamo la realtà, diamo un senso alle cose condividendole con altri individui. Il mondo diventa mondo nel momento in cui entra a far parte della nostra lingua[4], nel momento in cui ad una precisa concatenazione fonematica si aggiunge un’immagine rappresentazionale dotata di senso e significato valida per tutti i membri appartenenti a quella data comunità linguistica; vale a dire il sinolo[5] per antonomasia costituito da un significante a cui viene associato un significato in un costante e continuo gioco-forza tra arbitrarietà e attrito reale, tra convenzionalismo e naturalismo[6].
Essa è un fatto naturale, ma anche un prodotto della cultura
in grado di avere una certa retroazione su di essa. Ci basti, in questa sede, constatare un fatto di per sé banale e rinomato per dimostrare questa duplice essenza: ogni lingua possiede un proprio arsenale di frasi idiomatiche, che possiamo anche definire collocazioni fraseologiche, cioè accostamenti sull’asse sintagmatico di parole il cui valore non è dato dalla semplice somma delle singole componenti. In italiano standard, ad esempio, si utilizza l’espressione idiomatica è una parola! per indicare che una determinata azione o una determinata cosa che si vuol effettuare o raggiungere, è difficile da compiersi se non impossibile[7].
Come detto, il valore significativo della fraseologia
non deriva dalla semplice somma dei suoi componenti, infatti provando una traduzione letterale della proposizione idiomatica in inglese non solo no si riesce a trasmettere lo stesso meta-significato che possiede in italiano, ma addirittura non avrebbe proprio alcun senso (trad. ingl. it’s a word). Alla stessa categoria appartiene anche il napoletano nun è ccose che sta a significare ‘non è il caso’, ‘non è opportuno’, anche qui tradurlo in italiano significherebbe perdere completamente il senso originale (trad. ita. non è cosa)[8]. Questa semplice constatazione ci dimostra come un sistema segnico di significazione linguistica non consista solo ed esclusivamente in una giustapposizione di un segno ad un elemento ideale, non si tratta di un semplice dare etichette o nomenclature al mondo, ogni lingua storica naturale ritaglia i fenomeni extralinguistici ed il materiale semantico a propria discrezione, secondo i propri criteri che sono a loro volta stabiliti dalla cultura d’appartenenza.
La realtà viene conseguentemente razionalizzata,
padroneggiata e penetrata intellettualmente; la lingua diventa così, storicamente, il bacino fertile entro il quale nascono le ideologie, la cultura, le categorie ermeneutiche di interpretazione del mondo (Weltanschauung), appropriandosi simbolicamente di tutto ciò che la circonda secondo le proprie coordinate esistenziali. La conseguenza più evidente, date le nostre premesse, è che il dialetto ha espresso, per un lungo arco di tempo ed in certi contesti continua a farlo, il patrimonio culturale delle comunità collettive che ne fanno uso, riassumendo in sé quel vasto, molteplice e stratificato insieme di conoscenze e competenze che usualmente va sotto il nome di tradizione o tradizione folcloristica o cultura popolare.
Ogni lingua segmenta e stratifica la realtà
a proprio piacimento[9], quindi ogni lingua è lo stendardo più evidente della cultura e dell’appropriazione del reale per parte di una determinata e ben circoscritta collettività umana, indipendentemente dalla sua estensione demografica. A questo punto della nostra trattazione è d’obbligo rispondere ad una domanda che lentamente ha iniziato a serpeggiare, anche se in modo implicito, all’interno del nostro discorso: che cos’è un dialetto? Cosa si intende oggi per dialetto e soprattutto in cosa un dialetto sarebbe diverso da una lingua?
Nel corso degli anni si sono prodotte le risposte
e le spiegazioni più variegate ed eclettiche, spesso sfiorando solo leggermente il vero quesito, e questo perché, lo diciamo sin da subito, il concetto di dialetto è intrinsecamente vincolato alla storia che ha avuto il termine all’interno della nostra letteratura, da sempre ostracizzato dai canoni istituzionali ed intriso di giudizi valoriali che hanno prodotto la percezione implicita nei discenti che il dialetto sia un qualcosa di secondario e subordinato alla parlata nazionale, spesso inteso come indice di scarsa scolarizzazione e di carente ammobiliamento culturale.
Una prima spiegazione che ha tentato in passato di risolvere
il problema concettuale della differenziazione ontologica tra lingua e dialetto è quella basata su di un criterio che potremmo definire quantitativo[10]: un dialetto si differenzierebbe da una lingua in senso stretto perché usato in una circoscrizione territoriale meno ampia, e quindi da un numero molto più esiguo di abitanti. Molti sono stati gli studiosi e gli accademici che hanno appoggiato in pieno tale definizione, dichiarandosi d’accordo con una spiegazione ‘neutra’, che non implichi cioè un giudizio di valore nella discriminazione. Ma ad onor del vero si tratta di una definizione che non riflette la realtà; senza allontanarci troppo sulla linea del tempo, infatti, basti considerare la situazione linguistica italiana nel 1861, oppure immediatamente precedente il primo conflitto mondiale per dimostrare che la stragrande maggioranza dei parlanti della nostra penisola era dialettofona.
Un secondo criterio utilizzato nel tentativo di definire il fenomeno
è quello che identifica come ‘dialetti’’ tutte quelle parlate che, a differenza di una lingua vera e propria, non godono di una codificazione letteraria, cioè non presentano una veemente e rinomata tradizione scritta. Anche in questo caso, però, le cose stanno diversamente e ci si allontana di molto dal vero. Sempre limitandoci al contesto italiano, molti sono i dialetti che hanno una tradizione scritta letteraria con un certo spessore estetico-letterario, e che da sempre rientrano a buon diritto nelle antologie scolastiche di ogni tempo: opere in veneziano o in napoletano come quelle di Goldoni e Basile sono mirabili esempi di letteratura dialettale italiana. Anche questo criterio non ci soddisfa, manifestando palesemente una contraddizione rispetto al principio di realtà[11].
Un’ultima spiegazione che tenta di risolvere il conflitto,
nel tentativo di adoperare una definizione ‘neutra’, chiama direttamente in causa il rapporto filogenetico o grado di parentela. Stando a tali presupposti sarebbero ‘dialetti’ tutte quelle varietà idiomatiche, parlate e/o scritte, ancora in uso tra le popolazioni, che presentano una certa documentata affinità parenterale con un’altra varietà che, per complesse motivazioni di ordine storico–politico, è stata consacrata al ruolo di lingua nazionale o ufficiale. In altre parole si tratterebbe di una varietà parlata della lingua nazionale, una varietà dello stesso sistema linguistico di riferimento[12].
La definizione si presta ben volentieri a descrivere il panorama idiomatico
di molti Paesi in cui, effettivamente, c’è una lingua ufficiale e poi, perifericamente, tutte le sue varietà fenomeniche che condividono con essa lo stesso impianto/struttura di significazione. Ancora una volta, però, non è il caso dell’Italia. Nella nostra penisola esistono, senza dubbio, alcune parlate dialettali più affini all’italiano standard rispetto ad altre, ma molte di queste sono molto più affini ad altre lingue che non all’italiano: è il caso, ad esempio, dei dialetti del Piemonte centro-orientale oppure, più in generale, tutti i dialetti dell’Italia nord-occidentale, detti anche ‘gallo-italici’. Un altro esempio, invece, proviene dalla Lucania meridionale che, stando ad una seria comparazione, si sono più volte dimostrati tanto distanti dall’italiano quanto lo sarebbero il francese o il portoghese[13].
Nessuna di queste spiegazioni è in grado, quindi, di definire
in modo chiaro e preciso quale sia effettivamente la differenza tra una lingua ed un dialetto. La soluzione, alle volte, chiamando in causa il buon principio occamiano di semplificazione, è più semplice di quanto si creda; è necessario semplicemente cambiare prospettiva. La soluzione è impossibile perché sono i termini stessi con i quali indichiamo i due fenomeni a non ammetterla; ritorniamo a ciò che si era detto sin da subito: Un dialetto, giova ripeterlo, è un sistema linguistico autonomo rispetto alla lingua nazionale, quindi un sistema di codificazione con caratteri strutturali propri ed una storia ben distinta rispetto a quella della lingua nazionale.
Sul piano ontologico e strutturale,
tra dialetto e lingua non esiste alcuna differenza su tutti e quattro i piani architettonici del linguaggio; ad esempio tra il dialetto Cilentano della bassa Lucania, a cavallo tra Campania e Basilicata, e l’italiano. Tutti e due i sistemi di veicolazione comunicativa posseggono una propria fonetica, morfologia, semantica e sintassi. Tutti e due i sistemi hanno un loro vocabolario (ufficializzato o meno), vale a dire un proprio insieme lessematico aperto, ove sono presenti tutti i termini tesi ad inquadrare e classificare minuziosamente i vari settori dell’esperienza empirica (esiste ad esempio un vero e proprio ambito di studi in cui la dialettologia moderna si interseca con l’etnografia e lo studio dell’oggettistica quotidiana delle collettività dialettali che utilizzano parole specifiche per oggetti specifici, senza corrispondenza alcuna con l’italiano)
Solo la storia e la letteratura sono in grado di scovare
precisamente quale sia questo elemento discriminativo essenziale tra dialetto e lingua, una differenza che, come già anticipato, risiede nella molteplice stratificazione semantica del termine ‘’dialetto’’, una stratificazione di tipo storico e semantico al contempo che ha contribuito ad allontanare sempre più sul piano della percezione comune le distanze tra i nostri termini di paragone. Il termine dialetto, ormai venerando cultismo nella nostra tradizione linguistica italiana, affonda le sue remote origini nel greco classico, dialektos, che significa in primo luogo colloquio, conversazione, e solo in seconda battuta lingua, idioma di un determinato popolo; nel mondo latino il termine venne assunto quale calco linguistico nelle forme dialectos (alla greca) o dialectus, un vocabolo indicante la parlata locale assunta ad importanza letteraria.
Per questioni di chiarezza espositiva è necessario sottolineare
sin da subito che né in greco né in latino il termine presenta semanticamente giudizi di valore negativi, anzi le principali quattro parlate della Grecia ellenica continentale erano indicate proprio con il suddetto termine. Nell’antico contesto della Grecia di quel tempo vi erano infatti dei dialetti, cioè varietà linguistiche (attico, ionico, eolico, dorico) precisamente contrassegnate da un punto di vista diatopico; ad ogni parlata corrispondeva un territorio ben preciso, ma ognuna di tali parlate possedeva anche una sua precisa valenza letteraria (l’attico è la lingua della tragedia classica ad esempio); con il passare del tempo ognuna di queste varietà venne soppiantata dalla cosiddetta koiné dialettale, una sorta di lingua comune sovrastatale impiantata principalmente sulle strutture espressive di ionico ed attico e che garantiva la comunicazione tra le diverse popolazioni elleniche (all’incirca a partire dal III sec. A.C.).
Nonostante gli umanisti italiani della seconda metà del Cinquecento letterario
fossero pienamente consapevoli della sedimentazione semantica originaria del termine, iniziarono ad utilizzare quello stesso termine, ovviamente modellato secondo fonetica ed ortografia fiorentina, per riferirsi a tutte le parlate italiche al di fuori della lingua fiorentina-letteraria, ma soprattutto iniziarono a farlo con un’accezione di significato subordinata al concetto di lingua, intendendo esplicitamente una varietà linguistica meno prestigiosa. E’ molto probabile che il contesto in cui iniziò a crearsi questa seconda ma oggi preminente accezione di significato fosse quello di una netta opposizione tra un fiorentino parlato, meno prestigioso, ed il fiorentino classico di stampo trecentesco della ben nota tradizione dantesca e petrarchesca.
La nuova terminologia venne quindi estesa
alla situazione italiana in generale che, non casualmente, proprio nella seconda metà del Cinquecento viveva la cosiddetta questione linguistica; una vera e propria polemica letteraria intorno a quale tipologia di lingua si dovesse considerare in termini di norma linguistica, per poterla istituzionalizzare attraverso grammatiche, e cosicché gli scrittori italiani avessero finalmente un modello ideale e standardizzato a cui guardare nel loro far letteratura. Il resto è storia ben nota ai lettori: la soluzione prevalente fu quella di Pietro Bembo nella sua rinomatissima Prose della volgar lingua (1525) che impone l’imitatio esclusiva dei classici fiorentini trecenteschi; da quel momento in poi, il discente di lingua italiana percepisce nella stratificazione semantica del termine ‘dialetto’ un giudizio di valore sostanzialmente negativo che subordina il dialetto, ontologicamente, rispetto alla lingua nazionale. Ancora oggi i sondaggi ISTAT e DOXA dimostrano come il parlante italiano medio percepisca il dialetto quale indice di scarsa scolarizzazione e cultura[14], tralasciando l’enorme importanza archivistica e antropologica, oltre che linguistica, che ognuna di queste varietà linguistiche della nostra penisola porta in grembo ormai da secoli.
Note:
- [1] Il numero esatto sarebbe di 7.954, https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_d%27Italia.
- [2] Il comune di Moncenisio, nella regione del Piemonte, vanta ben 36 abitanti; altri comuni come ad esempio Morterone, Briga Alta e Pedesina, rispettivamente Lombardia, Piemonte e Lombardia, non arrivano alle 50 unità di abitanti; i dati fanno riferimento all’anno 2017.
- [3] Lingue e Dialetti d’Italia, Avolio, Francesco, Carocci Editore, 2017, pp. 20-21.
- [4] Celebre è la sentenza post-strutturalista secondo cui ‘i confini della mia lingua sono i confini del mio mondo’; per ulteriori approfondimenti sul tema Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein, Ludwig, trad. e introduzione critica di G.C.M. Colombo, Fratelli Bocca, Milano-Roma, 1954.
- [5] Concetto filosofico coniato da Aristotele designante una concreta sostanza concepita quale sintesi indissolubile di forma e materia; le due componenti sono inscindibili e consustanziali, nel senso che nessuna delle due sussisterebbe senza l’altra, vedi Metafisica, Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 2018.
- [6]Con la scoperta dei neuroni specchio per parte del team scientifico di Giacomo Rizzolatti è stato comprovato che il nostro linguaggio verbale sarebbe l’evoluzione astratta di un antico sistema comunicativo basato sulla gestualità; in questo senso il linguaggio verbale non sarebbe riducibile a mero sistema di codici convenzionali ed arbitrari, ma al contrario sarebbe in parte ancorato alla concretezza naturale di alcuni gesti pragmatici; per approfondimenti, So quel che fai, Sinigaglia e Rizzolatti, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
- [7] L’esempio è ripreso da Lingue e Dialetti d’Italia, Avolio, Francesco, Carocci Editore, 2017, pp. 20-21; L’immagine presa in analisi fa probabilmente riferimento, in modo esplicitamente ironico, al fatto che non si tratta di una cosa semplice come il naturale proferimento di una parola.
- [8] Ibidem
- [9] Il primo a sistematizzare il concetto fu F. De Saussurre nella sua opera Corso di linguistica generale, Losanna-Parigi, Payot, 1916
- [10] Lingue e Dialetti d’Italia, Avolio, Francesco, Carocci Editore, 2017.
- [11] Dialetto, dialetti e italiano, Marcato, Carla, Bologna, Il Mulino, 2007.
- [12] I dialects dell’anglo-americano sono varietà parlate dell’inglese degli Stati Uniti; per ovvie motivazioni i dialetti concepiti in tal senso hanno gli stessi caratteri strutturali e la stessa storia della lingua nazionale, vedi Dardano 1996, 171.
- [13] Lingue e Dialetti d’Italia, Avolio, Francesco, Carocci Editore, 2017.
- [14] Introduzione alla linguistica italiana, A.A. Sobrero, A. Miglietta, Roma-Bari, Laterza, 2006.
Bibliografia:
- Aristotele, Metafisica, Roma-Bari, Laterza, 2018
- Avolio F., Lingue e Dialetti d’Italia, Carocci Editore, 2017
- Marcato C., Dialetto, dialetti e italiano, Bologna, Il Mulino, 2007
- Platone, Cratilo, Roma-Bari, Laterza, 2018
- Sobrero – Miglietta, Introduzione alla linguistica italiana, Roma-Bari, Laterza, 2006
- Sinigaglia – Rizzolatti, So quel che fai, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
- Saussurre, Corso di linguistica generale, Losanna-Parigi, Payot, 1916
- Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, trad. e introduzione critica di G.C.M. Colombo, Fratelli Bocca, Milano-Roma, 1954
Articolo scritto da,
Claudio Oreste Menafra
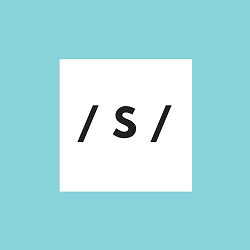









2 commenti su “I dialetti d’Italia, tra frazionismo linguistico e discriminazione valoriale”